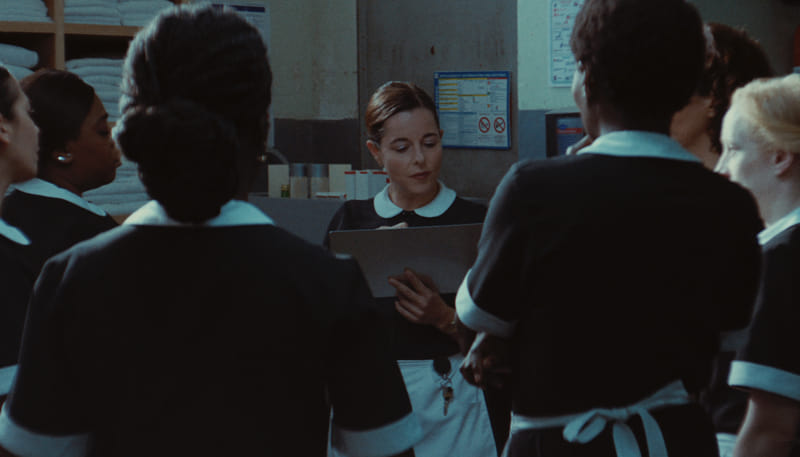Ambulance

C’è quasi sempre un inseguimento in auto al centro delle varie iterazioni del cinema di Michael Bay.
È un motivo che torna costantemente, da Bad Boys II a The Island, passando, ovviamente, per il franchise dei Transformers in cui gli scontri più spettacolari si svolgono durante lunghissime sequenze di corsa sulle autostrade. Per Bay l’highway americana è chiaramente uno spazio giocoso, che usa, spesso, per rileggere le coordinate di certi generi tradizionali, ma è soprattutto uno spazio sicuro, a cui torna spesso, per riprendere fiato, riposizionarsi all’interno del film, oppure ritirarsi quando qualcosa non torna.
Non è un caso, in effetti, che il suo nuovo progetto, Ambulance, sia non soltanto un film letteralmente fondato su un inseguimento stradale ma che, soprattutto, sia il progetto con cui Bay torna nello spazio della sala dopo la folle incursione su Netflix di 6 Underground, straordinario oggetto concettuale che sovverte le logiche della Franchise Age all’insegna di un approccio apertamente ricombinatorio. In 6 Underground nulla esiste al di fuori dello sguardo di Bay, che evoca e assembla gli elementi tipici del blockbuster in uno spazio sospeso, labilissimo, in cui ogni struttura può essere potenzialmente riconfigurata e tutto accade quasi nello stesso momento. Il risultato è un’ipertrofia che ammette qualsiasi spunto, qualsiasi linea tensiva e dà corpo ad una storyline in costante espansione, in cui i fatti si susseguono più per contiguità che per consequenzialità narrativa e l’unico punto fermo sembra essere l’immersività delle sequenze action.
Ma a Netflix i risultati del film non convincono e così chiude le porte ad un Michael Bay mai così lucido nel ragionare sulle potenzialità del cinema digitale.
E allora, davvero, in prospettiva, si fa fatica a considerare questo Ambulance come un semplice remake dell’omonimo film danese del 2005, su due fratelli costretti ad una disperata fuga dalla polizia dopo una rapina fallita. Si tratta di un progetto troppo personale, in cui troppo del cinema di Bay è in gioco, per non permettergli di dialogare con il resto della sua filmografia, per non considerarlo come il progetto con cui il regista, dopo la caduta nello spazio delle piattaforme, torna in sala per riflettere sullo stato di salute del suo cinema, quasi a voler ricostruire, aggiornare, il dialogo con il suo immaginario.
Ambulance è, almeno in apparenza, lo Yang di 6 Underground, un film che, forse non a caso, ricorda le produzioni Bruckheimer dei primi anni ’00 (in cui Bay ha iniziato), diretto, compatto, quasi intimo.
Ma il racconto, qui, è solo un pretesto per sostenere un progetto che ha al suo centro lo sguardo di Bay e la sua rieducazione. Quello di Ambulance è un processo graduale e tuttavia centratissimo, che si sposta tra i piani, gli spazi, i linguaggi. Si parte dalla dimensione analogica, da una Los Angeles costantemente mappata dalle traiettorie dell’inseguimento, per poi passare ai vertiginosi voli con le drone-cam, violento segnale della presenza del regista sulla scena e fondamentale strumento per prendere possesso degli spazi del racconto, fino a esorbitare nella moltiplicazione di quello stesso sguardo negli strumenti di sorveglianza per immagini, tra microspie, segnali gps, tracciati termici.

Mentre Bay riprende meticolosamente contatto con il suo cinema delle origini, il film assume un passo sempre più libero, strafottente, più interessato a costruire ambiziose coreografie con le auto in corsa e a disorientare lo spettatore tra le traiettorie di fuga, che a costruire una narrazione complessa. È un approccio mai così giocoso, quello di Bay (e non è un caso che uno dei referenti maggiori del film si ritrovi in quel Grand Theft Auto di cui Ambulance riproduce rituali e dinamiche), che tra l’altro, per la prima volta, si diverte apertamente a puntellare il film di evidenti citazioni alla sua filmografia, affascinante, definitivo show of power con cui il regista rende evidente la sua presenza sulla scena al di là di tutto e tutti.
Perché più che (o oltre a essere) una terapia, Ambulance è soprattutto un’inesorabile ed appassionato processo di liberazione della sintassi di Bay dalle ingerenze di quel cinema delle piattaforme che, appena qualche anno fa, stava per condurlo sull’abisso.
Affrancarsi di altri sguardi per riappropriarsi del proprio punto di vista, dunque e, magari, riprendere un discorso che era stato interrotto.
Perché, in fondo, nel tornare a quella velocità, a quel movimento costante che è il fondamento della sua estetica Michael Bay è ancora lì, interessato a teorizzare quello strumento di narrazione combinatorio, in perenne riconfigurazione che aveva sfiorato con Six Underground.
Il risultato delle sue ricerche si ritrova proprio nelle strutture essenziali di Ambulance. Perché quello attorno a cui prende il corpo il film è uno straordinario inseguimento “espanso” che tra le sue linee archivia, reitera, rilancia, alcune fondamentali svolte dell’action più o meno recente, tra il maxi tamponamento di Landis, il Fury Road di Miller, la jeep ipertecnologica e panottica del Deja Vu di Scott, l’ultimo atto dell’Heat di Mann, quello della disperata fuga a piedi per le strade di quella stessa Los Angeles.
Al contempo, ecco che quell’ambulanza in perenne movimento diventa fucina di nuove narrazioni, nuove dinamiche, tra scazzottate, sparatorie, momenti tensivi, vertiginose operazioni in corsa, all’insegna di quel parossismo narrativo che, paradossalmente, è stato teorizzato nello spazio digitale delle piattaforme ma è stata ottenuto solo in un contesto orgogliosamente analogico: quello della sala, certo, ma anche quello a cui fa riferimento un linguaggio, un approccio, lontanissimi dal tradizionale Bayhem, tutto ripiegato negli spazi del mezzo di emergenza o nelle dinamiche tra i soli tre protagonisti della storia.
Pur fondato su una forsennata corsa a perdifiato per la salvezza, Ambulance è dunque, per certi versi, il primo vertiginoso film d’interni, ennesimo paradosso di un progetto affascinante proprio per il modo in cui devia, esorbita dalle attese a causa della sua urgenza: un relitto del passato che però riflette sul medium con uno sguardo attualissimo, un film eccessivo, esorbitante e che tuttavia si regge solo sullo sguardo del suo regista, pronto, forse per la prima volta, a confrontarsi con la sostanza stessa del suo cinema, senza preoccuparsi delle conseguenze, pronto, piuttosto, ad accogliere con curiosità tutto ciò che emergerà dal dialogo.