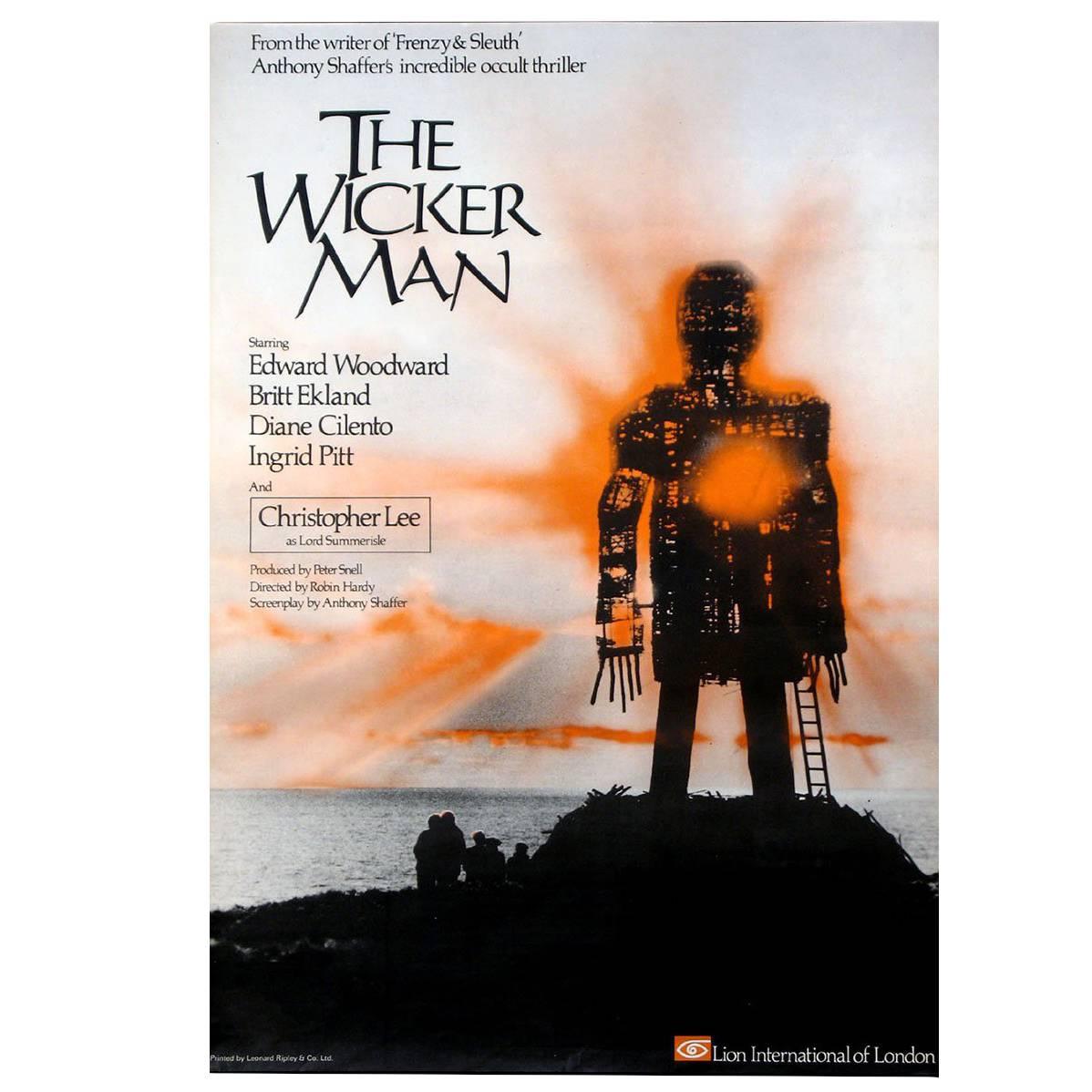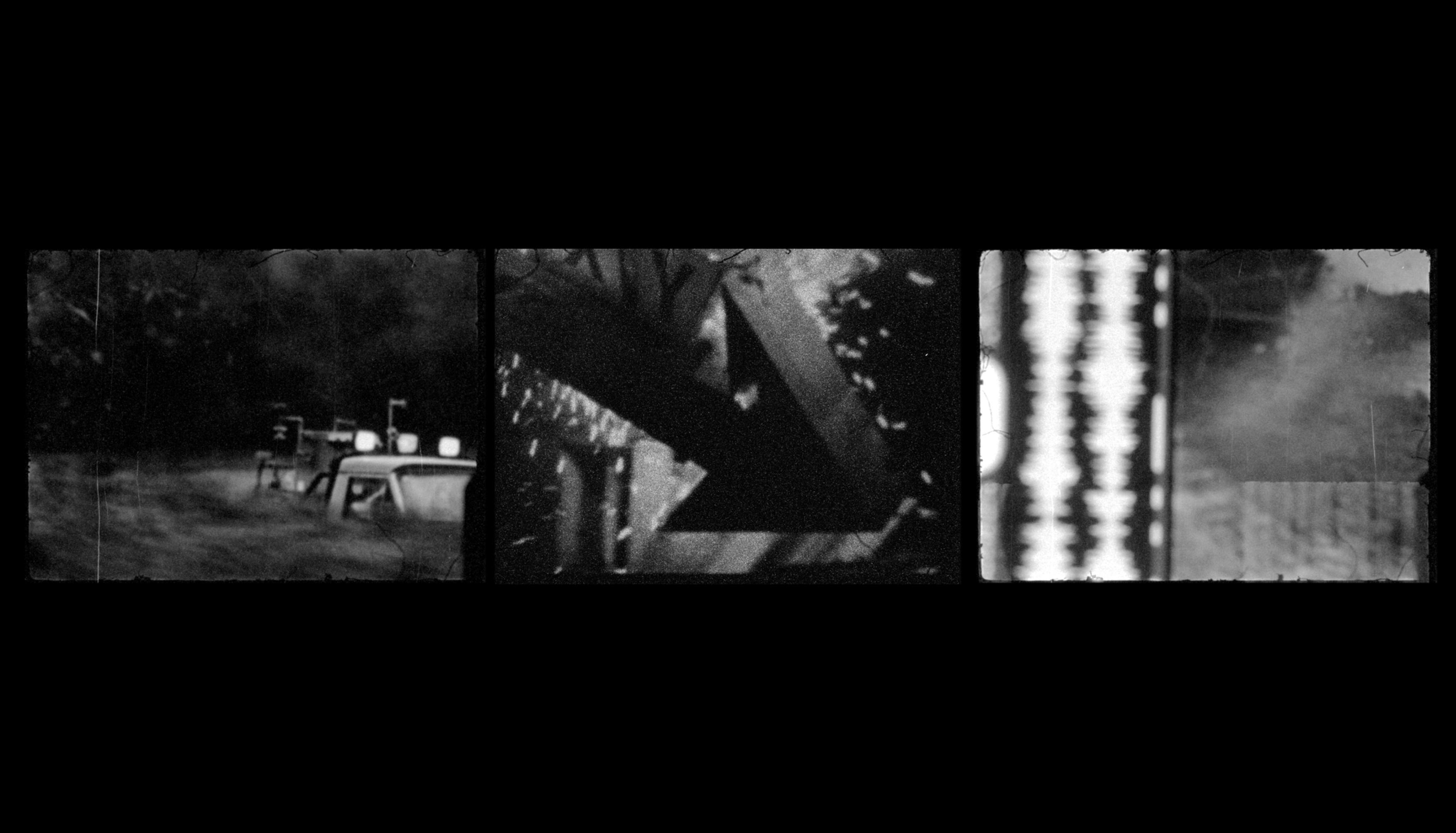One Day, You Will Reach the Sea

«Non guardarti indietro». È una delle prime frasi che compaiono fluttuanti nell'onirico incipit di One Day, You Will Reach the Sea, diretto da Ryutaro Nakagawa e presentato al Far East Film Festival 2022, ma è anche uno dei moniti più ricorrenti e nefasti nella nostra cultura. Sono le parole che, nella Genesi, gli angeli rivolgono a Lot dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra e soprattutto è la condizione imposta da Persefone a Orfeo per poter condurre l'amata Euridice fuori dagli inferi. Ma esistono anche delle contronarrazioni, o meglio, diverse accezioni, sfumature, punti di vista sensibilmente differenti sulla concezione del passato, come nella cultura giapponese. Un cambio di percezione che emerge iconograficamente e socialmente, attraverso uno dei soggetti più ripresi nelle pitture e nelle stampe nipponiche del diciassettesimo secolo, quello di una donna raffigurata mentre si volta (le Beltà di Hishikawa Moronobu), e con lo Shōwa Day, la festa nazionale (nel giorno della nascita dell'imperatore Hirohito) che più che celebrare il passato invita a guardarsi indietro e riflettere, per proiettarsi poi verso il futuro. È il percorso che segue Mana, la protagonista di One Day, You Will Reach the Sea, che nella prima scena appare proprio di spalle, voltandosi lentamente e svelando il volto rigato dalle lacrime, in un'immagine che si mostra subito eloquente. Il passato verso cui guarda la ragazza è quello che la vedeva in compagnia di Sumire, una compagna di studi, coinquilina ma soprattutto una persona a cui era legata da una forte amicizia, scomparsa nel 2011 in occasione del terremoto e del conseguente maremoto del Tōhoku. Se con il tempo la madre e l'ex fidanzato di Sumire sembrano aver elaborato il lutto, il peso dell'assenza è ancora insostenibile per Mana e opprime il suo presente tra pareti di dolore. Nakagawa sottolinea questa condizione attraverso l'uso quasi totale di scene in interni (fino al momento della svolta) e con inquadrature che comprimono i personaggi, Mana in particolare, sovrastata ad esempio dalla porta della camera dell'amica, che rievoca tutta la sua angoscia. Non può quindi trattenersi dal voltarsi verso il passato, non come via di fuga o per rifugiarvisi, ma per esplorare la mancanza, per rivivere l'intimità di un rapporto che si stava sbiadendo anche prima della morte di Sumire, per rinsaldare ricordi che rischiano di scivolare via. Ma soprattutto perché quel passato fa parte inevitabilmente del suo presente.
Il racconto si dipana attraverso flashback che ripercorrono le tappe della loro amicizia, momenti che si pongono in netto contrasto con le sequenze del presente, caratterizzati da spazi aperti e dalla radiosità di immagini e paesaggi come espressione dello splendore del loro rapporto. Un legame definito non dalle parole, che fluiscono lasciando dietro di sé non detti e velate suggestioni, ma dagli sguardi, dai silenzi, dalle pause, dal loro sfiorarsi casuale e istintivo. Ciò che si crea oltrepassa l'amicizia sino a diventare quasi un amore latente che vive esclusivamente nell'immagine, senza essere pronunciato. Mana sembra prenderne coscienza proprio tramite la rievocazione e l'osservazione del passato ed è anche per questo che il dolore risulta lacerante e apparentemente impossibile da mitigare, a causa di sensazioni irrisolte, arginate prima da una sorta di pudore e da una progressiva lontananza e poi in modo definitivo dallo tsunami. Il percorso di elaborazione passa attraverso una ritrovata consapevolezza e dalla rilettura dei ricordi; un viaggio sia fisico che spirituale che riconduce Mana nel luogo in cui Sumire è scomparsa. È proprio lì, oltrepassando un'imponente barriera bianca, che richiama la grande onda e al tempo stesso simboleggia il suo senso di oppressione, che i fantasmi di Mana trovano pace, di fronte agli spazi illimitati del mare. Nonostante il dramma sia innescato dal mare stesso, esso non viene visto secondo la logica della violenza della natura, quanto piuttosto, seguendo la tradizione giapponese, come l'elemento di forte legame tra la natura e gli esseri viventi. L'acqua e il mare ricorrono spesso in One Day, You Will Reach the Sea, con carrellate a sorvolarlo, ad accompagnare alcuni momenti del rapporto tra le due ragazze e soprattutto nelle due commoventi e oniriche sequenze d'animazione, che esprimono perfettamente il senso di trasformazione e di connessione che è alla base del film e che riguarda anche i vivi e i morti, oltre che il passato e il futuro e la natura e gli esseri viventi. Mana e Sumire sembrano infatti continuare a comunicare anche dopo la morte di quest'ultima, attraverso tempi e spazi differenti, e il loro percorso appare confluente.
One Day, You Will Reach the Sea affronta quindi, dando luce all'anima del Giappone e con una cura dell'immagine, una sensibilità e un'armonia affini a certi anime, il delicato tema dell'elaborazione del lutto, riflesso dalla fase di crescita post-adolescenziale, dalla perdita dell'amicizia, dall'amore inespresso ma legato anche ai ricordi e al lutto nazionale, relativo alla tragedia del Tōhoku. Storia pubblica e privata si intrecciano, a partire dall'ispirazione del regista, che cercava un'occasione per poter riflettere e ripensare (guardarsi indietro, appunto) al dramma che ha colpito il Giappone e a un episodio della sua vita personale. Il film pone anche una riflessione sulla natura dell'immagine, e di conseguenza sul cinema, con la videocamera appartenuta a Sumire e ritrovata dal suo ex fidanzato. Era un oggetto imprescindibile per la ragazza, da cui difficilmente si separava e che utilizzava per riprendere scene quotidiane. Una sorta di secondo punto di vista e di filtro, che la appassionava perché era consapevole che di ciò che ci circonda vediamo solo un lato. Viene osservato dunque il ruolo delle immagini, nel rapporto tra campo e fuori campo, visibile e non visibile; singole finestre sul mondo a cui attribuiamo un significato e che lasciano un segno, come le interviste ai parenti di alcune vittime del maremoto nel finale. È proprio grazie alle immagini ritrovate nella videocamera che vengono colmate le lacune della percezione legata a un unico punto di vista e che il passato di Mana assume una nuova luce. E di conseguenza il suo presente.