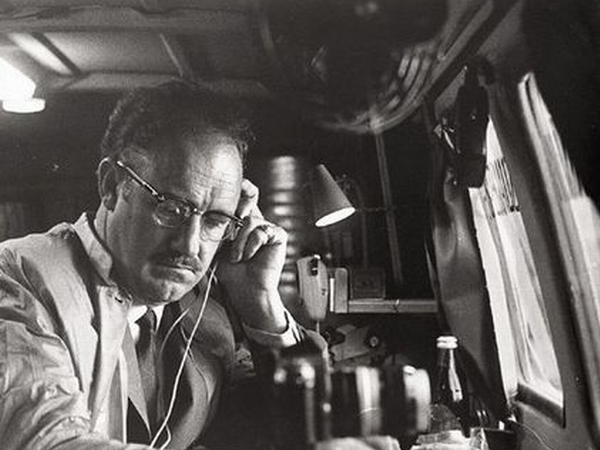All Hands on Deck

C’è, in All Hands on Deck (À l’abordage), ultimo lungometraggio di Guillame Brac (presentato nella sezione Panorama della Berlinale 2020 e mai uscito nelle sale italiane, ma recentemente disponibile su MUBI per un certo periodo), tutto un condensato, il sedimento stesso, del suo cinema. Una sorta di cremore depositato sul fondo dei suoi metabolismi (d’uomo e d’artista) che come in un bâtonnage risale in sospensione, s’agita e si rimescola con la sostanza più liquida, mutevole, delle sue creazioni. Facendo in modo che il carattere intrinseco del suo pensiero per immagini persista, affinandosi, di film in film. La vacanza intesa come spazio di liberazione del desiderio, ad esempio; l’estate come quintessenza del debordare, della vitalità che può finalmente straripare fuori dagli argini dei giorni contenuti, trattenuti, del tempo feriale, dell’ordinario; i giovani come unici possibili portatori di questa ebrezza, di questa febbre di vita; la dimensione dell’incontro tra persone e mondi, in cui si materializza la fugacità ma al tempo stesso l’incanto dello stare assieme. E poi, ancora, gli aspetti metodologici, produttivi, le scelte riguardanti il processo di lavoro, che determinano, inevitabilmente, la natura stessa, l’anima del film: i budget risicatissimi, la scrittura calibrata sugli attori, la predilezione per interpreti ignoti al grande pubblico, presi direttamente dalle classi del Conversatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD), e di non professionisti, il ricorso all’improvvisazione, la mescolanza tra elementi fiction e non fiction.
In tal senso tutti i lungometraggi e i corti precedenti, da Le Naufragè a Un monde sans femmes, da Tonnerre a Contes de juillet, fino a L'Île au trésor potrebbero essere visti come propedeutici all’ultimo lavoro di Brac, À l’abordage. Ciascuno di essi nasceva dalla volontà di filmare dei giovani attori provenienti dal Conservatoire (in particolare Vincent Macaigne, Julien Lucas e Laure Calamy) e traeva spunti narrativi e stilistici direttamente dalle loro esperienze di vita, dai loro ricordi e confessioni, collezionati dal regista con appositi incontri durante la fase letteraria del film, in un processo di scrittura aperto e osmotico, che si lascia permeare e fecondare dalla realtà. E che porta tutto il cinema di Brac a snodarsi con un certo fascinoso equilibrio fra invenzione e realmente accaduto, immaginazione e osservazione, preordinato ed estemporaneo; peculiarità che conferiscono ai suoi racconti un’estrema vitalità e immediatezza senza per questo pregiudicare la validità e la tenuta dell’ossatura, della struttura di base, su cui il regista innesta le gemme che prende dal reale, dalla viva voce di quei giovani che poi si ritrovano dentro il film.
Da questo punto di vista è interessante constatare come le recenti politiche di selezione dei propri allievi da parte del CNSAD – con cui Brac ha sempre collaborato e che gli aveva richiesto di scrivere un lungometraggio appositamente per la classe 2020 (che poi sarebbe diventato, appunto, À l’abordage) –, maggiormente improntate a riflettere l’eterogeneità etnica, sociale, sessuale e culturale della Francia contemporanea, si siano tradotte nella possibilità di riflettere in modo ancora più fecondo sul tema dell’incontro, tanto caro al regista francese. I due protagonisti, Félix e Chérif (interpretati da Eric Nantchouang e Salif Cissé), non appartengono alla borghesia bianca che può solitamente permettersi vacanze e ferie: sono giovani studenti-lavoratori di colore e la loro presenza non può che essere pregna di significato. Entrambi devono ricorrere a compromessi e stratagemmi, alcuni spassosi, altri molto più amari, anche solo per passare qualche giorno di libertà lontano dalle sbarre di una quotidianità fatta di lavori malpagati e futuro incerto. A differenza di Alma e di Édouard, bianchi e figli di una classe sociale certamente più privilegiata.
Così come L’Île de loisirs di Cergy-Pointoise in cui era ambientato il precedente L'Île au trésor veniva raccontata come luogo di mescolanze, di pluralismo di sguardi, di corpi e relazioni, così il campeggio del Sud della Francia in cui si svolge la storia di À l’abordage diventa uno spazio di convergenza e divergenza, di incontro-scontro tra giovani che appartengono alla stessa generazione ma a contesti anche molto diversi tra loro. Una ricchezza che Guillaume Brac continua a filmare con grande intelligenza e partecipazione, senza enfasi alcuna e senza fredde distanze, preservando, anche da un punto di vista fotografico e nella direzione attoriale, l’intensità semplice ma toccante dello stare al mondo.