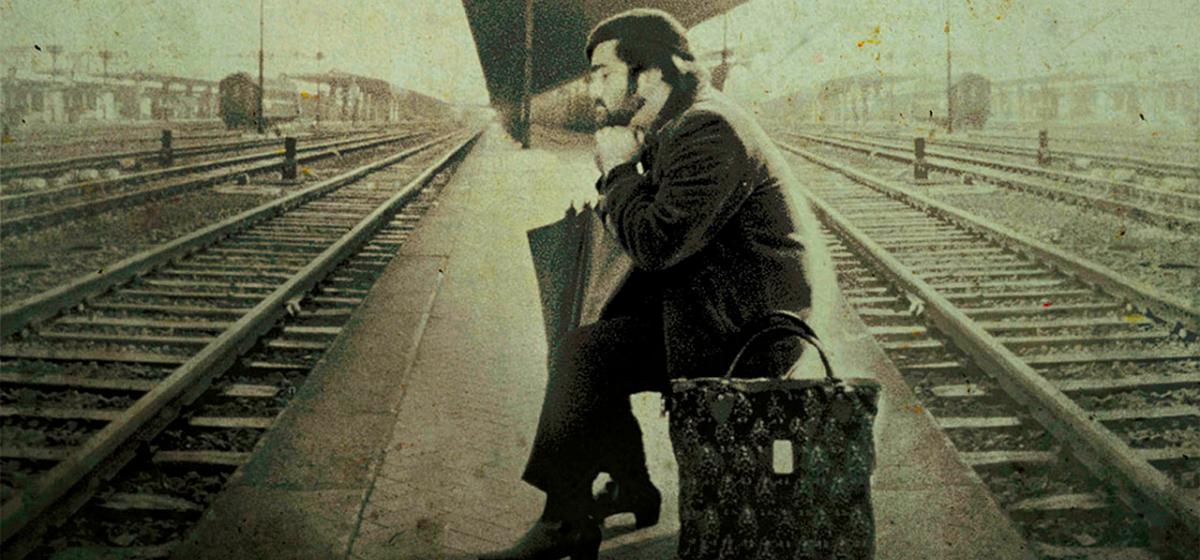France

Fa parte del circo mediatico, France. Oppure, in senso critico, è la reinstallazione nell’oggi della società dello spettacolo di debordiana memoria: un luogo sociale dove tutto è rappresentazione, ogni spazio è di messinscena. Oppure ancora, nell'idea di Dumont, è l’annullamento della linea di separazione tra il cinema e la televisione: perché anche la televisione è cinema, secondo l’autore belga, visto che del cinema utilizza i trucchi dell’illusione, dalla forma narrativa fino al montaggio per manipolare l’immagine e indirizzare lo sguardo. Così, all’inizio di France, l’ultimo film di Bruno Dumont, la protagonista France de Meurs (Léa Seydoux) si trova totalmente immersa nella rappresentazione: fa domande a Macron, in un campo-controcampo che è il trionfo del fake, segue l’esercito francese accanto agli arabi “buoni” contro gli estremisti. Tutto falso, tutto in posa: la dialettica diegetica tra campo e fuori onda lo attesta chiaramente, stiamo assistendo a una recita. Facile, becera, prevedibile. Che conferma la chiacchiera da bar: è tutto preparato.
Poi però nella vita di France accade qualcosa. Un banale incidente: investe un giovane arabo, un migrante non bello, l’estetica in Dumont è sempre politica. Lo specchio si rompe. France esce dal circo a cui partecipa e inizia a guardarsi da fuori, ma attenzione: non lo fa per l’investimento in sé, che ha un peso tramico importante ma etico relativo, bensì perché si ritrova sulla copertina di un settimanale scandalistico, non più come star ma come pirata della strada. Viene fagocitata dal congegno che contribuiva ad alimentare. Un po’ come, dal basso, avviene per il protagonista dell’ultimo grande film di Asghar Farhadi, A hero, che finisce gradualmente triturato dal meccanismo della reputazione su cui faceva leva. E, sempre dal basso, riscritto in tragedia, per il sindacalista al centro di In guerra di Stéphane Brizé, che non poteva far altro che sfruttare la mediaticità per costruire il gesto estremo. Insomma, France è sulle cover e tutto cambia: la reazione della donna, inaspettatamente, è il pianto. France/Léa infatti si mette a piangere: in qualsiasi situazione, in modo eccessivo, non riesce a trattenere le lacrime e anche la sua lacrimazione rischia di entrare nell’ingranaggio. Allora smette, lascia la televisione.

La permanenza di France nel centro di riabilitazione segna un’altra svolta, fingendo un melò per finire in horror. La finta di Dumont si concretizza nel personaggio di Charles (Emanuele Arioli), che sembra disegnare un’ipotesi di amore vero, sincero per la protagonista: ma è solo un giornalista, un cronista sotto mentite spoglie, uno che deve scrivere un articolo. Ecco la svolta paurosa, terrificante: il sistema mediatico ti insegue, non ti lascia andare, non puoi liberarti di lui. Nell’agghiacciante truman show di oggi, peggiore dell’originale, anche il sentimento è recitazione, e l’inganno dell’amore si fa più crudele perché consumato su un magnifico sfondo montuoso da cartolina. France ci sta dentro comunque, che lo voglia o meno: tanto vale rientrare davvero. Il suo ritorno nello studio-set può portare l’inciampo definitivo, la gaffe esiziale sul tema cardine del nostro tempo: i migranti. France sta cercando di allestire un falso servizio su un gommone (e piange, ovviamente), una sorta di riscrittura finzionale di Purple Sea, il piccolo film “rivoluzionario” di Amel Alzakout e Khaled Abdulwahed, con la regista siriana che cade davvero in acqua coi migranti e continua a riprendere (vedetelo su MUBI). France cade in un altro modo: mentre lancia lo scoop registra il fuori onda che svela l’inganno, il cinismo, il sorriso sulla pelle dei poveracci.
Potrebbe essere la fine, ma la ruota della rappresentazione si limita a girare: “basta” un altro incidente, la morte di figlio e marito, per essere avvolta nel velo del lutto e quindi di nuovo compatita, ben vista, ben guardata. A quel punto pare giunta la presa di coscienza: “Esiste solo il presente”, dice France. Ma cos’è il presente? È una passeggiata per strada, nel mondo vero, mentre un disperato, che sembra uscito da P’tit Quinquin, prende a calci una bicicletta e la distrugge. Senza motivo. Solo un piccolo atto di violenza.
Tutto questo, però, non va preso sul serio. Perché il registro di Dumont è un altro: il grottesco. Ecco il punto. Il cineasta rifiuta il realismo e lo smentisce attraverso certi particolari. È proprio con la deformazione grottesca che racconta la sua storia, la mette in scena: non è forse grottesco un personaggio che si chiama come lo Stato in cui vive, in un atto di sovrimpressione sfacciata, ma anche di hybris, come Paris Hilton che si chiama Parigi? Non è grottesco il suo vestiario scintillante quanto esagerato, che cambia continuamente cromatismo? E alcune comparse, come la donna ossessionata dalle celebrità e il ricco che teorizza il capitalismo come forma d’amore? Ma, soprattutto, il grottesco si annida nelle espressioni: i volti e le pose sono sempre troppo, troppo cariche, troppo tenute, prolungate per alcuni secondi in più rispetto all’economia drammatica convenzionale. Si pensi solo all’assistente di France, la Lou di Blanche Gardin che dice cose assurde, che funge da puntello paradossale a ogni situazione. E alla stessa protagonista, naturalmente. D’altronde il sistema mediatico è un vortice senza soluzione, in quanto condensato perfetto dell’ultra-capitalismo visto dall’anti-capitalista Dumont: non resta allora che la parodia, non si può fare altro che prenderlo in giro. E France? Non le resta che piangere.