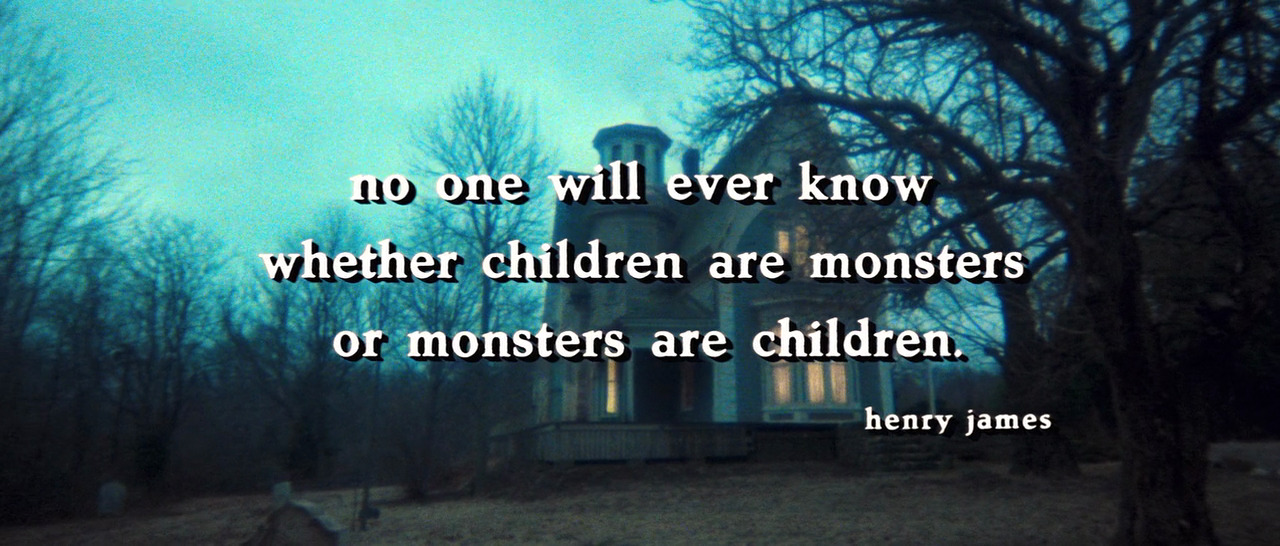Dopo il nero, in fondo, non si può che ripartire dall’abisso. Bisogna come al solito muoversi in parallelo, giocare su più tavoli e, soprattutto, ammettere di trovarci a contatto con un sistema che si muove con tempi rapidissimi. Si è discusso a lungo, proprio su queste pagine, di spazio analogico infiltrato dal digitale, di nuovi paradigmi visivi, di un cinema dei dati che sta acquisendo sempre più forza, identità, fagocitando anche le icone di un immaginario eminentemente di carne e sangue, di cui svela, anzi, in prospettiva, il debito con lo spazio digitale, come accaduto con Tom Cruise in Mission Impossible - Dead Reckoning Parte 1.
Appena una manciata di mesi fa terminava questa prima guerra mediale ed è già il tempo di leccarsi le ferite, di riflettere sulle conseguenze del trauma, di processare questo impatto, magari sintetizzando un vero e proprio vocabolario di motivi, di strutture ricorrenti utili a raccontare la crisi. E in The Creator sembrano esserci tutte o quasi: l’avanzatissima intelligenza artificiale creata dagli americani, la bomba nucleare che l’AI sgancia, pare autonomamente, su Los Angeles, la conseguente guerra senza quartiere lanciata da America ed Europa contro questa tecnologia senza volto, inconoscibile (e la Cina, emblematico, che prova a convivere con questo nuovo ecosistema) e infine un soldato disilluso incaricato di dare il colpo di grazia all’Intelligenza Artificiale ma che finisce, irrimediabilmente, per empatizzare con il bersaglio.
Ma si parlava di abisso. Perché a Gareth Edwards, forse il primo creativo che, per caso o necessità, si è trovato a doversi confrontare con le conseguenze dell’impatto, va in effetti riconosciuta una lucidità straordinaria nell’affrontare la questione. Non fa un passo indietro, lascia intendere che la lotta, la resistenza, tra l’uomo e la macchina siano soprattutto una questione di facciata, in realtà l’esito dell’ennesimo scontro di civiltà è già tutto scritto nello splendido prologo che racconta gli antefatti della guerra. E lo fa posizionandosi già al di là del linguaggio e del medium cinema in senso convenzionale, optando piuttosto per un ibrido che unisce finto repertorio con i filmati Educational che raccontano l’ingresso dei robot nelle fabbriche già negli anni ’50, estratti di false sedute del Congresso colte con panoramiche da fly on the wall e altrettanto artefatte ricostruzioni storiche di eventi mai avvenuti. Il punto di partenza, è evidente, è la lezione postmoderna di Zemeckis, che in Forrest Gump infiltrava il suo protagonista nei meandri della Storia. Gli intenti, però, sono evidentemente agli antipodi.
Manca, in effetti, l’ironia del postmoderno. C’è, piuttosto, la consapevolezza che quanto sta avvenendo di fronte allo spettatore non sia la realtà, ma neanche una sua rappresentazione prettamente “cinematica” in senso stretto. Ce lo dice la sintassi, ce lo dicono i formati, certo, ma ce lo dice anche, forse soprattutto, questa strana fatigue, quest’affanno che si percepisce tra le immagini, il loro desiderio di avvicinarsi alla rappresentazione di uno spazio credibile ma mai veramente decifrabile dai sensi. E allora emergono le ammaccature, le incertezze, i falsi positivi, le visioni involontariamente inquietanti, malgrado il sistema cerchi di “dirti” che ciò che stai vedendo è tutto vero. È il trionfo del deepfake, il prologo di The Creator, squadernato, tuttavia, senza alcun intento esibizionistico ma quasi lasciando intendere che, ora, le uniche immagini possibili al cinema sono quelle “pensate” ed elaborate dai dati, dall’intelligenza artificiale, afferenti a contesti sempre più lontani dalla concretezza del reale. Gareth Edwards ha colto il potenziale mitopoietico dell’IA, la possibilità dello spazio digitale può accogliere nuovi immaginari, nuove mitologie a partire da immagini che hanno una loro forza, una loro credibilità intrinseca. È vero, il suo è un ragionamento a grana grossa e, per certi versi, pare limitarsi a proseguire un discorso che, tra gli altri, era già in nuce in un film come The Gray Man praticamente nato a partire dalla ricombinazione di spunti, spazi, linee pre-esistenti, ma tra il film Netflix e The Creator c’è un abisso. Perché per Edwards tutto pare perduto, tutto va ricreato da zero, gli input precedenti sono ormai relitti, non troppo dissimili da quelli che, in effetti, il protagonista è incaricato di scandagliare per lavoro. E allora tanto vale sfidare lo spettatore, immergerlo in uno spazio straniante, interrogare la tenuta dei suoi sensi.
Avrebbe tutto il potenziale per essere un film densissimo, The Creator che sembra voglia rileggere in chiave contemporanea quella paranoia del digitale che già era nel cinema dei primi anni ’00 di un autore come Tony Scott e che, a ben vedere, insisteva in domande simili (dov’è la verità, ad esempio, in un mondo di immagini false ma così convintamente vere? cosa vuol dire reale? come si guardano queste nuove immagini?). Ma quando Edwards è chiamato a dire la sua si blocca, spiazzato da una crisi della referenzialità che ha innescato ma che in realtà, a ben vedere, non sa come gestire. Quasi lo spaventa, tant’è che, emblematicamente la relega allo spazio sonora, da cui improvvisamente emerge, all’apice del primo atto, quell’Everything Is In The Right Place che è il singolo con cui i Radiohead tentarono di raccontare le paranoie della internet culture nel 2001. È come una resa, una fuga in altri spazi perché ci si rende conto troppo tardi di non avere il fiato e la forza muscolare per sviluppare la lettura ipotizzata in un primo momento. E allora, spaventato dal peso delle sue argomentazioni, o forse, perché no? dalle risposte, inquietanti, ambigue, che avrebbe potuto trovare “dall’altra parte”, The Creator fa un passo indietro e quasi si contraddice.

Disperato, Edwards cerca la referenzialità a tutti i costi, lavora sulle superfici, costruisce grossomodo ogni cellula visiva o narrativa del suo film a partire da quei prelievi da cui, almeno inizialmente, pareva voler prendere le distanze. Come per rassicurare gli spettatori che in fondo nulla è cambiato, che i regimi della rappresentazione sono ancora quelli noti, che le regole del gioco sono quelle condivise. Ma è un meccanismo di difesa che prevedibilmente mostra le sue falle senza troppe difficoltà, che forse regge solo quando insiste sulle zone canoniche del cinema del suo regista, sulla sua fascinazione per i War Movie, per l’estetica sporca delle campagne americane in Vietnam o in Iraq, i cui tratti distintivi sembrano tornare costantemente tra le immagini, come fossero incubi inconsci di un’intera nazione che infestano anche le distopie più remote.
Per il resto è un film sempre più stanco, The Creator, sempre più rigido, che pare ravvivarsi solo quando si rende conto che lo spettatore ha intuito il suo gioco referenziale e portato alla luce, in modo tutto sommato semplicissimo, tutti i riferimenti, le influenze, gli spunti su cui si costruisce. Ma allora quella di Edwards non è più un’idea di cinema futuro ma piuttosto una fiacca caccia al tesoro che passa da Terminator e Blade Runner, sfiora le estetiche urbane di Neil Blomkamp, costeggia certe inquadrature prese di peso dal precedente Rogue One ed esonda in un ultimo atto che pare fare il verso al prologo di Call Of Duty - Infinite Warfare, forse uno dei pochi veri colpi di reni di un film che in chiusura almeno torna a quello sguardo oltre il cinema da cui era partito. Edwards si nasconde sullo sfondo, quasi schermato dalle ambientazioni curatissime, dagli oggetti di questo mondo sci-fi che pare non riuscire a essere altro che un freddo diorama o, ancor meglio, un artwork di Ralph McQuarrie o Simon Stålenhag (eccolo, ancora, prigioniero della reference a tutti i costi). La regia, la scrittura, non entrano mai davvero in gioco perché al film manca tutta la pars costruens, la forza che leghi un vero e proprio discorso argomentativo a partire dalle tematiche affrontate dal film. Beninteso, è evidente che a tratti sfiori certe intuizioni per certi versi fenomenali, anche solo per il modo in cui prova a raccontare il futuro con sguardo quasi solar punk, rileggendo in chiave luminosa il rapporto tra uomo e tecnica, sfiorando quasi la tecnomagia, tra mani giunte in preghiera che lanciano impulsi EMP e robot che officiano funerali. Ma si tratta di illuminazioni momentanee, che la scrittura lascia emergere senza mai davvero argomentarle, senza mai partire da esse per fondare quel paradigma, interpretativo e visivo, annunciato nelle prime immagini, quasi si accontentasse di lasciare certi elementi allo stato grezzo perché tanto basta, tanto è sufficiente a rassicurare chi guarda che la tecnica, la tecnologia, forse non sono strutture così apocalittiche, respingenti, come potrebbe sembrare, dopotutto.
È un film apodittico, The Creator, che accetta le sue idee come ovvietà, un falso movimento, solo in apparenza proteso verso il futuro e in realtà straordinariamente contemporaneo, soprattutto per il modo in cui porta in scena e prova a contrastare quelle che sembrano alcune delle maggiori fobie del presente: la paura della perdita dei propri punti di riferimento, la paura di non comprendere più come previsto ciò di cui lo spettatore fruisce.