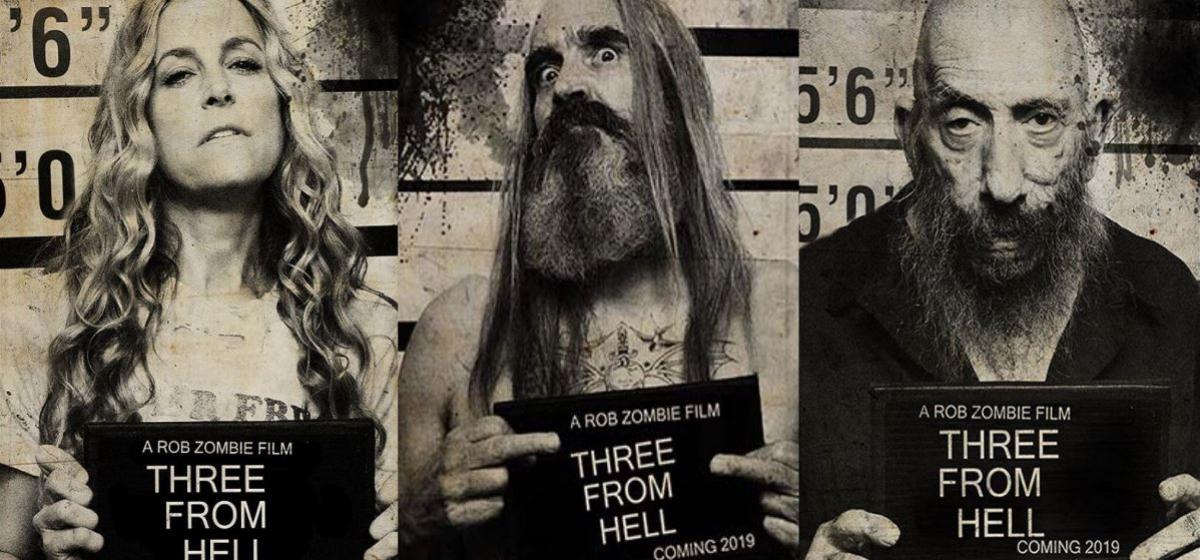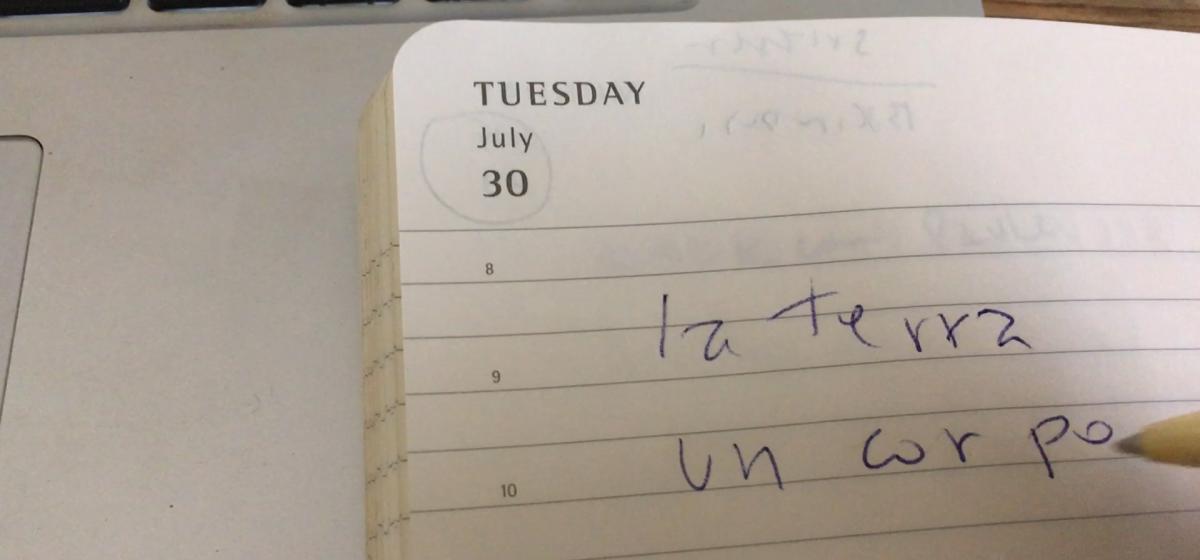Thunder from the Sea

Nel buio imperscrutabile di una collina, la camera di Yotam Ben-David non fa nulla per assistere il nostro occhio di spettatori e facilitarne la visione, lasciandoci spaesati e liberi di rintracciare da soli qualche segno, forse il movimento di un corpo che potrebbe esserci, o magari no. E in questa oscurità, in cui si distinguono quasi soltanto le sagome degli alberi e le sonorità proprie di uno spazio naturale, quando ci accorgiamo per davvero della figura di qualcuno che si porta in avanti tra i cespugli, abbiamo l’impressione che una primissima adesione alla materia filmica sia già avvenuta. Come se la nostra rapida introiezione in uno spazio che non conosciamo ci abbia spinto ad analizzare puntigliosi l’immagine per contravvenire al nostro spaesamento, al nostro stato di inadeguatezza. Senza alcuno sforzo apparente, il regista israeliano ottiene tutta l’attenzione che cercava già con la scena di apertura al film, Thunder From the Sea, premiato con il Laceno d’oro alla 44esima edizione del festival avellinese.
In questa spazialità notturna e confusa, quasi scoordinata, localizzati soltanto dalla striscia luminosa d’un paio di scarpe da ginnastica e da una (improbabilmente funzionante) insegna al neon gettata tra i cespugli, i giovani Udi, Doron e Dekel si danno appuntamento per fumare narghilè e per raccontarsi episodi pescati casualmente dalle proprie memorie. Parlano in particolare di omosessualità (la loro), di violenza irreprimibile per vendicare un tradimento amoroso, ma pure accennano ad argomentazioni vagamente teoriche e complesse che a un tratto ritagliano, da un richiamo di riflessione sugli ebrei aschenaziti dell’Europa orientale, un principio di considerazione sull’etica dello stato israeliano. Parlano con la naturalezza propria di una sceneggiatura che conosce e si alimenta dei sentieri intricati che mappano le geografie di queste giovani anime. Nella ripartizione non sistematica dei primi piani innocentemente sorridenti dei personaggi, rischiarati soltanto dalle luci cangianti dei neon, si definisce il loro bisogno di confinamento protetto, la necessità d’uno spazio personale, intimo, che rifugga dalle turbolenze di Tel Aviv e che custodisca i loro segreti, altrimenti inconfessati. L’autenticazione di sé e l’intimità del messaggio possono essere esperite soltanto all’interno di questa bolla, di un’alterità non localizzabile che ovatta e attutisce la minaccia esterna. Eppure, quantunque ci si allontani, le avvisaglie del pericolo e del suo sconfinamento non tardano a manifestarsi, e questo Ben-David lo sa bene.
L’ululato del coyote intercetta e interrompe per un attimo la confessione di una triste memoria, quella della fucilazione di un bambino appena sfiorata. Il cielo già scuro si veste di un nembo che richiama da lontano la possibilità di una tempesta. Persino la collera attraversa quest’isolamento, minacciando di disintegrare le maglie di un rapporto creduto solidissimo. E se una violenza impensata può inopinatamente deflagrare, ricorre a sedarla, almeno per questa volta (sembra voler comunicare il regista israeliano), l’intesa coordinata di un triplice sguardo tra i compagni, retaggio di un rapporto saldato lungamente negli anni. Quanto ancora si può sfuggire alla minaccia di un tempo che si consuma inesorabile e cancella le polveri di una fratellanza, l’illusione di un’età da viversi ancora innocentemente? C’è forte coesione nell’opera vincitrice del Laceno d’oro, in cui traspare efficacemente tutt’una tensione espressiva necessaria a instillare cautamente questa domanda, assecondando il lento incedere di una tempesta, primo piano per primo piano, avvisaglia per avvisaglia. Alla fine, quasi con la percezione di una umana protervia, il tuono prorompe stentoreo a farsi presenza e a rompere l’attesa del titolo, ponendo una cesura al sogno della giovinezza.