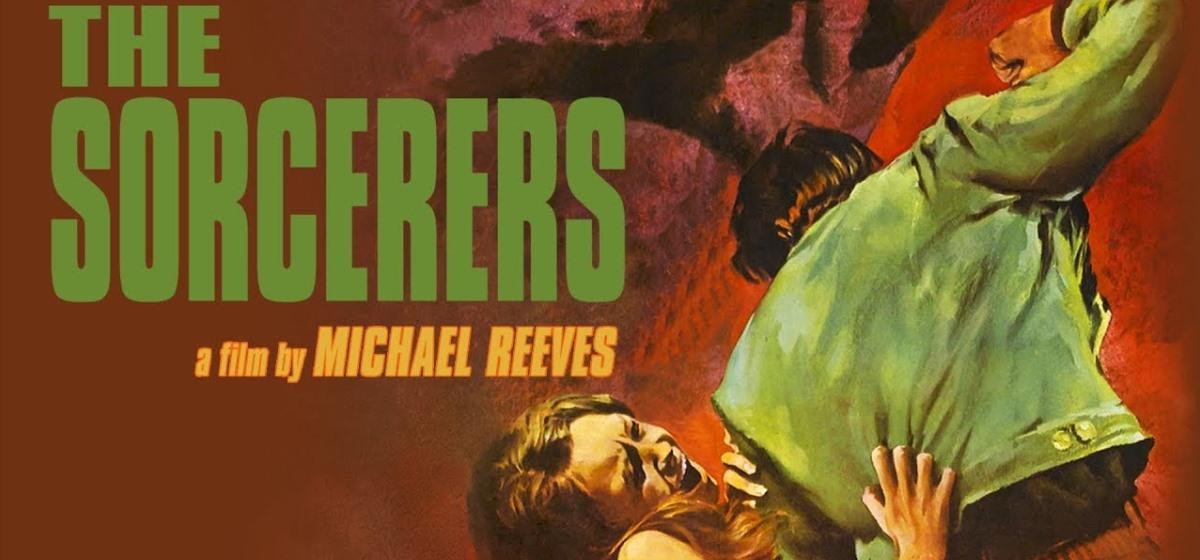Senza lasciare traccia

Debra Granik ritorna, otto anni dopo Un gelido inverno, a una storia di marginalità, resistenze e sopravvivenza. Una storia di padri e figlie, di convivenza e divergenza, di bisogni e abbandoni, dentro un’America che sceglie di curare i propri traumi lontano dal progresso, alla ricerca di nuove (e vecchie) frontiere, tra civiltà e wilderness, dove rifondare se stessi. Senza lasciare traccia ci immerge nel verde dei boschi del grande Nord Ovest americano, nei dintorni di Portland, e racconta la “disobbedienza civile” del reduce di guerra Will (Ben Foster) e della figlia preadolescente Tom (la nuova scoperta Thomasin Harcourt McKenzie), osservati nel loro simbiotico adattamento a una natura edenica e incontaminata, divenuta, da tempo, casa (per Tom) e rifugio (post-traumatico per Will), fino a che rangers e assistenti sociali non li scoprono per integrarli (invano) in un ordine sociale prestabilito.
Frontiere geografiche e frontiere interiori si mescolano in questo film che è una tenera ballata sulle relazioni umane e sulle corrispondenze tra individui e luoghi in cui vivere. Lo sguardo della Granik si posa amorevolmente sulle figure degli esclusi di questa America remota e poco conosciuta. In Un gelido inverno era una giovanissima Jennifer Lawrence ad agire in un mondo rurale e feroce di povertà atavica, in cui imparare a sopravvivere dopo la scomparsa di un padre finito chissà dove. Nel documentario Stray Dogs i bikers veterani del Vietnam sono outsiders come Will, guastati dalle politiche del paese e troppo fuori controllo per integrarsi (ancora) nella macchina sociale che li ha creati.
Leave No Trace - ispirato al romanzo My Abandonment (2009) di Peter Rock - respira letterariamente Walt Withman e la vita nei boschi del Walden di Thoreau, ma si nutre anche delle canzoni di Woody Guthrie, degli inni alla libertà del viaggio della cultura beat, del nomadismo hobo e dello spirito pionieristico alla base della fondazione del paese. Si appropria dei miti fondativi della cultura americana senza però romanticizzare nulla. Molto lontano da un film gemellare per tema (ma sensibilmente differente) come Captain Fantastic, più caustico e appariscente, l’opera della Granik si rivolge a uno spaccato umano vicino a certi lavori di Kelly Reichardt (soprattutto Old Joy e Wendy and Lucy) nel trattare un Altrove americano da attraversare per trovare il proprio posto, calando la storia in un minimalismo narrativo privo di climax, senza indicare cosa è giusto, senza eroi e senza antagonisti, al riparo da facili sentimentalismi e lezioni morali.
Lo stile è dimesso, l’occhio della regista, discreto e ravvicinato ai personaggi, aderisce al loro sentire e al respiro della foresta; a tratti ha un incedere documentaristico, come se volesse cogliere, con interesse antropologico, le relazioni all’interno delle comunità più sperdute di un’America viscerale - nascosta allo sguardo di un turista ma profondamente reale - che non cerca un paradiso perduto ma ha smarrito da tempo la fiducia nelle promesse di un sogno (o semplicemente a quel sogno non ha mai creduto).
Padre e figlia non riescono a fare dell’America urbanizzata moderna un posto in cui sentirsi a casa e troveranno durante la fuga da ogni integrazione possibile altri individui come loro. Uomini e donne che vivono in case mobili, senza possedere nulla se un desiderio di isolamento e libertà. Troveranno canzoni intorno al fuoco dove ritrovarsi per stare insieme. Non c’è solitudine, non c’è l’America spietata e crudele di Un gelido inverno qui. C’è il cuore di un paese che viene in soccorso gli uni degli altri, come dentro un alveare.
Il film segue l’evoluzione del legame padre-figlia trasformando il racconto in un coming of age. Mentre Will si porta dentro i disturbi di una guerra che sta ancora combattendo con se stesso, impossibilitato a vivere sotto un tetto che non sia quello della volta celeste delle foreste dell’Oregon, Tom sviluppa un desiderio diverso a quello del genitore che costringerà entrambi a un duro confronto e maturazione.
Leave no trace è una folk song d’amore tra un padre e una figlia - che imparano l’uno dall’altra vicendevolmente ad aiutarsi e lasciarsi liberi di trovare il proprio posto nel mondo - ma anche tra un’autrice e il paesaggio umano che popola i margini, senza urlare denunce ma con sguardo emotivamente e umanamente partecipe.