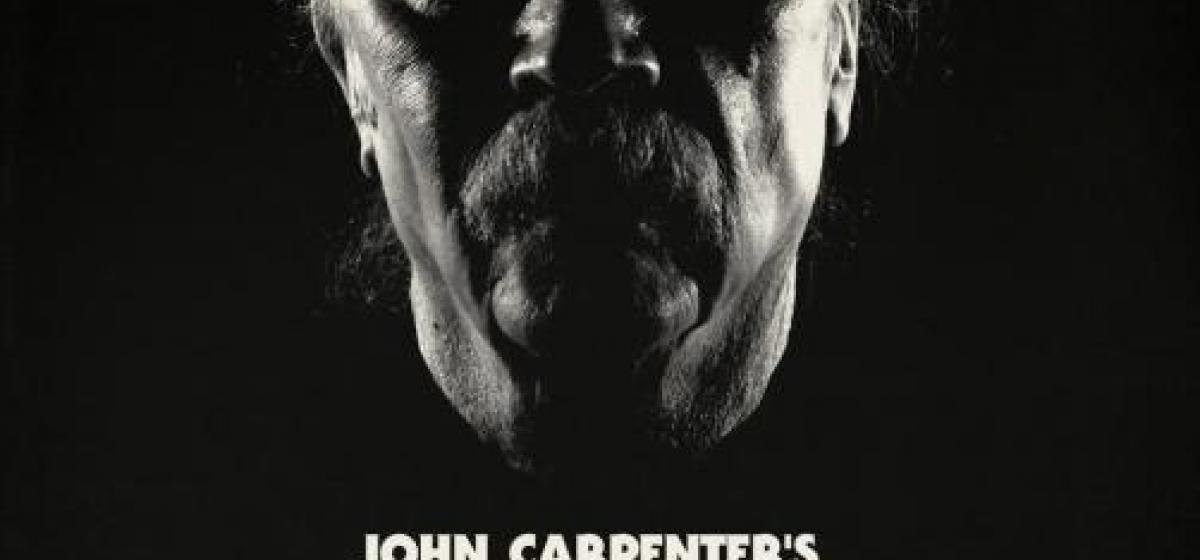American Sniper - The Bullet Man
Il cecchino è un uomo-fucile, la cui soggettività si definisce a partire dalla relazione con l’arma e dalla propagazione sempre più impersonale dell'uccisione, come naturale espressione di sé

La guerra dalla prospettiva di un cecchino ha un sapore del tutto particolare: si è al contempo dentro e fuori l’azione, si occupa fisicamente il campo di battaglia ma da una posizione privilegiata, a distanza, lontano dalla concitazione dello scontro a fuoco.
Lo si fa per vedere meglio naturalmente, sia i nemici che i compagni da difendere. In questo spazio separato il cecchino vive una vita parallela rispetto a quella dei suoi commilitoni, una sorta di reclusione a cielo aperto in cui l’azione, il gesto di morte, si misura nei lunghi intervalli che si succedono tra un colpo e l’altro, tra l’individuazione di un bersaglio (sempre inconsapevole) e lo sparo. Il tempo del cecchino è apparentemente immobile, una stasi perpetua che può durare alcune ore o persino una notte intera senza che accada nulla, come una lunga pausa dalla quale però non ci si può concedere pause, come nella sequenza notturna di American Sniper che si concluderà con l’uccisione del "macellaio". La morte allora diventa, nella sterile ripetitività della guerra, un fatto eccezionale eppur quasi automatico, sempre uguale che non ammette differenze qualitative, o eccezioni di sorta, donne o bambini che siano. La dannazione del cecchino sta tutta qui: in una condizione apparentemente privilegiata – perché ammette, al contrario della fanteria, la possibilità di scelta – che si ribalta nel contrario: ovvero nella condanna ad uccidere senza neanche l’alibi dell’istinto di sopravvivenza. Ogni sparo è attentamente calcolato, studiato nei minimi dettagli. La facoltà di scelta non è che un’illusione di libertà che corrode lentamente l’animo, perché, in fondo, non c’è alternativa alla morte.
E’ questa inevitabilità della situazione-guerra a trasformare il soldato in un automa (affatto spirituale, al contrario del modello bressoniano), letteralmente in un occhio che uccide. Un bullet-man, per citare l’amato Tsukamoto che sul divenire altro da sé, nel punto di congiunzione più alto o più basso, certamente più “letale”, tra l’uomo e la macchina, ha costruito una mirabile carriera (e in tal senso non appare così forzato vedere nella breve sequenza del meccanico, con il suono ossessivo della pistola/trapano fuori campo, un misto di paura e fascinazione che il protagonista nutre per il metallo). Il cecchino di Clint Eastwood è, dunque, un uomo-fucile la cui soggettività si definisce a partire dalla relazione con l’arma e dalla propagazione sempre più impersonale dell’uccisione come naturale espressione di sé, riflesso (in)condizionato delle terminazioni nervose, della carne e della mente. E non basta di certo il ruolo di cane pastore a rendere meno amaro il proprio compito, sebbene sia proprio questa “missione”, di diretta emanazione paterna, a permettere il ribaltamento dei termini “morali” della questione (non quante persone si è ucciso ma quante non si è riuscito a salvare).
Ecco allora che Eastwood, fuggendo qualsivoglia tentazione determinista, ci racconta, con la storia del cecchino più famoso d’America, la parabola di una nazione condannata ad uccidere e ad accettare la morte come un fatto ineludibile. Basterebbe quel magnifico raccordo sonoro che tiene insieme l’uccisione del bambino con l’iniziazione al fucile a dirci la complessità del film (e il suo legame segreto con Boyhood, altro importante racconto sul Texas). Sarà proprio quello sparo ad inaugurare il lungo flashback sulla vita del protagonista, inscrivendola nella morte e nel sangue, come segno distintivo di un’esistenza anonima illuminata dal talento per le armi da fuoco. Un talento naturale che si è consolidato a partire da un contesto culturale preciso, al quale Kyle crede sinceramente. Al punto da tramandarlo alla progenie nonostante i 160 morti, i traumi e le cicatrici, più morali che fisiche, che reca su di sé.
In tal senso appare emblematica la breve sequenza che anticipa il finale: Kyle insegna al figlio ad usare il fucile, proprio come il padre aveva fatto con lui. Non sembra esserci scampo: la triste sorte dell’uomo, consumato dalla propria abilità, è destinata a ripetersi ancora - pensiamo, ad esempio, alla pistola da cowboy che Kyle lascia in cucina, segno premonitore di quello che di lì a poco si compirà e soprattutto minaccia di un pericolo sempre in agguato. Il finale beffardo, relegato intelligentemente fuori campo, appare allora come un tragico appuntamento con il destino, non più rinviabile. Tanto più tragico perché avviene nel medesimo spazio occupato simbolicamente dal cecchino durante il conflitto, ovvero fuori dall’immagine-guerra. Come una sorta di colpa da estirpare: quella del Good Kill lontano/vicino dal campo di battaglia. La bellissima sequenza della tempesta di sabbia, oltre a porre fine alle ostilità, appare come l’ultimo atto nell’arte della guerra “novecentesca”, prima dell’avvento definitivo dei droni telecomandati, di cui si serve Ethan Hawke nel sottovalutato film di Andrew Niccol. Un accecamento che, come hanno fatto notare in molti, presuppone una nuova visibilità separata dai corpi e in cui all’uomo-fucile, per quanto infallibile, viene sostituito l’occhio-meccanico, manovrabile a distanza con un semplice joystick direttamente da "casa".
Questa dimensione quotidiana, lambita in parte nel film di Eastwood, che alterna con ripetitività la dialettica tra spazio privato e scenario bellico - e che sovente trova un punto d’incontro con l’ausilio dei cellulari - avrà la sua affermazione qualche anno più tardi, quando l’assassinio, definitivamente sottratto a qualsivoglia principio eroico, diverrà un lavoro d’ufficio non molto diverso da quello di un impiegato.