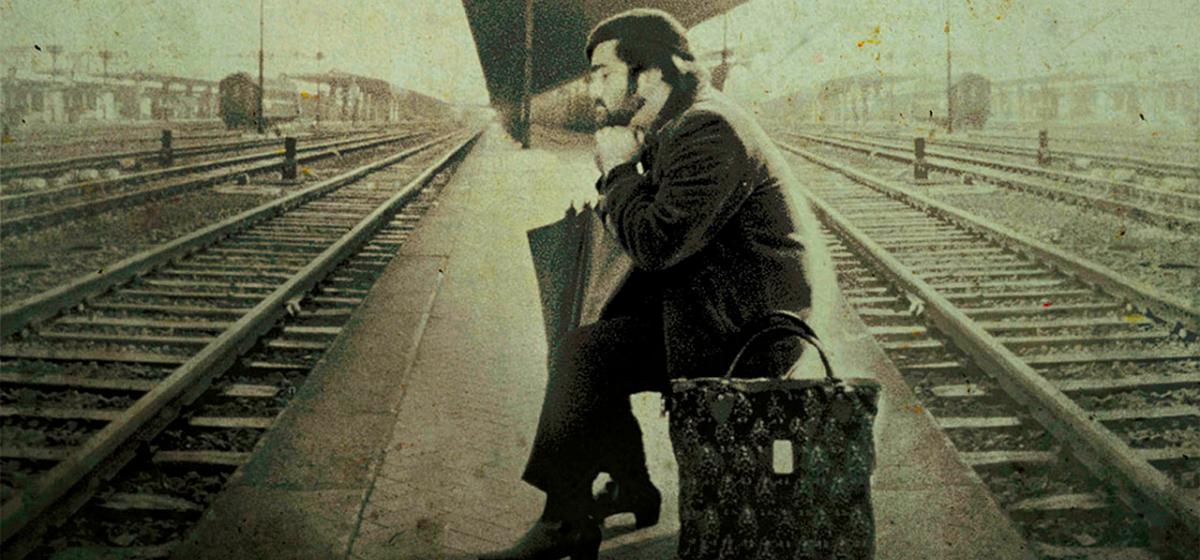Il documentario Lucciole per lanterne, realizzato dai registi Mario e Stefano Martone, porta inscritto sin dal titolo un indirizzo programmatico di lettura, che partendo dal monito proverbiale a non commettere un errore in forza di un fraintendimento invita lo spettatore a contemplare orizzonti di riflessione di ampio respiro.
Gli autori portano all’attenzione dell’opinione pubblica (promuovendo non a caso e funzionalmente anche canali di crowdfounding) la realtà di dissenso e strenua protesta delle popolazioni della Patagonia Cilena che, a seguito della privatizzazione delle risorse idriche del paese risalente ai tempi del regime di Pinochet, tutt’oggi rivendicano e oppongono i propri diritti di cittadinanza attiva ai diritti di sfruttamento dei corsi d’acqua sul territorio, detenuti dai colossi industriali transnazionali, i quali di contro, fedeli alla logica del profitto incondizionato, considerano le popolazioni locali stesse come agenti accessori, clausole di negoziazione ai fini della speculazione idroelettrica. Una questione, dunque, apparentemente lontana, se non fosse che quelle stesse ricchezze naturali rientrano tra i più grandi interessi dell’ENEL, l’azienda italiana in parte statale, che nel 2008, contestualmente all’acquisto della compagnia energetica spagnola Endesa poi divenuta Endesa Cile, istituisce ENEL GREEN POWER, multinazionale operante nel mercato delle energie rinnovabili.
La dissimulazione dello scollamento di una politica industriale a sfondo ecologista da una imprescindibile etica della politica ecologica stessa, suggerisce di soffermarsi sulla comune tendenza a confondere la concezione di “ciò che è bene” col valore di “verità”. Secondo la distinzione dello storico e filosofo del linguaggio Tzvetan Todorov, per “bene” si dovrebbe meglio intendere lo scopo, le finalità, l’orientamento, cui verranno piegate determinate risorse e pratiche. Un modo di agire inscindibilmente legato al complementare “bene per chi/per cosa?”, un accertamento nella sua sostanza, dunque, soggettivo e pertanto sempre sottoponibile ad un giudizio di valutazione sulla base di criteri ragionevoli e condivisibili, se impostati sul principio che vuole l’uomo e il suo habitat come fini ultimi e non come mezzi strumentali. La “verità”, invece, è in se stessa un valore oggettivo, idealmente indipendente dalle convenienze esterne, e che in quanto tale deve essere sempre ricercata e tutelata nella sua completezza. Poste tali premesse il documentario non può non far riaffiorare alla mente, in una prospettiva più estesa e complessa, il referendum del Giugno 2011, in cui i cittadini italiani espressero la loro contrarietà ad ogni forma di privatizzazione dell’acqua nel proprio paese, ignorando con ciò di lasciar gestire altrove allo Stato, attraverso l’ENEL, la medesima questione, ma in modo diametralmente opposto.
Ecco allora l’abbaglio, la confusione, lo scarto tra bene e verità sommerso, camuffato, contraffatto, prima di potersene avvedere. Sarà valsa la pena di dilungarsi fin qui nel chiarimento di certi dati storici di fatto e di punti focali di prospettiva per addentrarsi criticamente e lucidamente nell’alveo ideologico di matrice pasoliniana con cui i Martone suggellano sin dall’incipit la propria politica autoriale. La frase di chiusura del celebre articolo firmato da Pasolini nel 1975, “Io, ancorché multinazionale,darei l’intera Montedison per una lucciola”, dissolve infatti dal nero la prima sequenza del documentario. Sancendo metaforicamente “la scomparsa delle lucciole”, l’intellettuale-poeta, testimone consapevole dei suoi tempi, denunciava la scomparsa inesorabile e irrimediabile degli ultimi baleni di una umanità intrisa di valori autentici ed essenziali, quelli della civiltà contadina paleocapitalistica, sacrificati sull’altare dello sviluppo industriale e consumistico coatto, che era riuscito dove avevano fallito i regimi dittatoriali ovvero deformare le coscienze, dissociarle da secoli di vita codificata dalla terra di appartenenza, dalla trasmissione di memorie e di identità. “L’inquinamento simbolico”, che Pasolini imputava all’indifferenza del potere politico tout court, senza distinzione di sorta, era il deterioramento del più profondo patrimonio intergenerazionale condiviso, “la possibilità che un uomo anziano possa riconoscere nei nuovi giovani il giovane che è stato”, rompendo un secolare passaggio di consegna esistenziale. La perdita culturale ed emotiva era inestimabile, eppure nessuna forza di opposizione non solo era sorta per frenare l’accelerazione del processo di omologazione ma neppure pareva rimpiangere tale smarrimento. L’insensibilità diffusa era un atteggiamento imperdonabile per Pasolini. Il tempo dell’innocenza era ormai tramontato senza che nessuna coscienza dell’accaduto fosse subentrata al suo posto. Non poteva che essere persa in partenza una lotta che non era neppure iniziata.
![]()
Mario e Stefano Martone recuperano in modo “esemplare” l’eredità pasoliniana (come vorrebbe la teoria todoroviana di una Memoria come Exeplum, chiave di lettura del presente, anziché ripiegamento sul passato e che muova ad abbandonare uno status esclusivo di vittima per guardare piuttosto all’altro da sé) per scovare dietro le contingenze della sconfitta delle minoranze cilene, dei barlumi di resistenza, certo sommersa e addolorata, ma ancora vigile. È infatti nell’ottica della persistenza nonostante tutto, nonostante la lotta impari che contrappone la rigidità e l’anonimato della supremazia delle leggi del mercato globale, ai volti marcati dall’ostinazione e dal tempo, alle voci flebili ma lapidarie delle singole testimonianze vive che deve essere collocato Lucciole per lanterne, affine all’opera critica Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze, in cui lo storico dell’arte Georges Didi-Huberman, scandagliando il tono apocalittico dell’ultimo Pasolini alla luce della sua intera produzione letteraria, giunge ad affermare l’esistenza autonoma di certe “immagini-lucciole”, resistenze di coscienza e di pensiero differente, che pur celate e rare scompaiono solo quando si cessa di cercarle.
Le sequenze restituite dal documentario si palesano infatti intenzionalmente da un lato come cosmomorfizzazioni dell’universo rurale nei volti e dall’altro come antropomorfizzazione degli stati d’animo nei paesaggi. Visioni simbiotiche di vita, di donne icone della vitalità pragmatica e sentimentale dell’intera collettività, con la terra stessa. Emblematiche le immagini di Berta, anziana nativa dei luoghi, al Parlamento Cileno già nel 1988, mentre denuncia laconica il colpo che la trafigge in un diritto inviolabile, l’accesso e la disponibilità delle fonti d’acqua per coltivare le proprie terre, allevare il bestiame, continuare a vivere in definitiva come i suoi avi, senza dover temere un’inesorabile condizione di siccità. Una condizione di non vita, secondo la sua originaria visione di vita stessa. Di converso altre voci rotte dalla tristezza e dalla rassegnazione non lasciano mai il campo a lacrime sul viso bensì a singole gocce d’acqua che accarezzano le foglie e a leggeri rovesci di piogge sul fiume. Pianti inequivocabili che non riescono a scongiurare le seguenti premonizioni di morte simboleggiate dalle carcasse di animali. L’ecosistema di quelle terre incontaminate, ideali per gli impianti idroelettrici d’avanguardia, sono gli stessi abitanti al pari della vegetazione e delle catene montuose. Da tempo immemore gli uni custodiscono le altre, costruendo ponti generazionali impossibili altrove. Perché nell’altrove, merce di scambio delle multinazionali, non potranno mai vivere i medesimi abitanti. Per questo un uomo a cavallo attraversa un ponte ripreso frontalmente, avvicinandosi alla camera fissa in una prospettiva che appiattisce lo sfondo, smarrendo illusoriamente l’altro capo del ponte stesso. “Da dove viene quel passato?” si chiederanno i suoi discendenti che hanno perso il contatto diretto con l’antico sentimento di appartenenza e conoscenza dei luoghi. Quali ponti potranno mai gettare quest’ultimi, non avendo potuto coltivare le proprie radici!
Queste le riflessioni in voice over che animano il paesaggio silente. Se, dunque, la descrizione delle stato attuale delle cose, compreso l’attivismo dei comitati locali, interlocutori non riconosciuti come portatori di interessi di diversa natura – la stessa natura – lasciano poco spazio alla speranza di una risoluzione loro favorevole, l’ultimo dei fraintendimenti che gli autori del documentario si incaricano di risolvere è quello affidato alla citazione conclusiva della scrittrice indiana Arundhati Roy, impegnata sullo stesso fronte anti-globalizzazione. Condicio sine qua non della volontà di sperare è la volontà di immaginare la possibilità della speranza stessa, e l’immaginazione non può trovarsi nelle stanze delle conferenze sui cambiamenti climatici, ma “si trova in basso, raso terra, abbracciata alle persone” (si direbbe facoltà e risorsa distintiva, esclusiva e inesauribile dell’umanità che si preserva tale, contro ogni alienazione eterodiretta).
“Il primo passo per immaginare da capo un mondo che ha preso una direzione assurda, sarebbe fermare l’annientamento di chi immagina cose diverse, con una immaginazione che mostra idee diverse di cosa siano la felicità e l’appagamento”. Lottare primariamente per tener viva l’immaginazione come uno spazio filosofico radicale, faro di rivendicazione di uno spazio successivo, tangibile e fisico. L’epilogo prescelto pare dunque confermare l’ipotesi di Didi-Huberman, per cui agli occhi spenti di Pasolini non sono le “lucciole” ad essere scomparse, bensì qualcosa di ancor più viscerale, il suo desiderio di riconoscerle, fagocitate da quei miasmi carichi di morte.