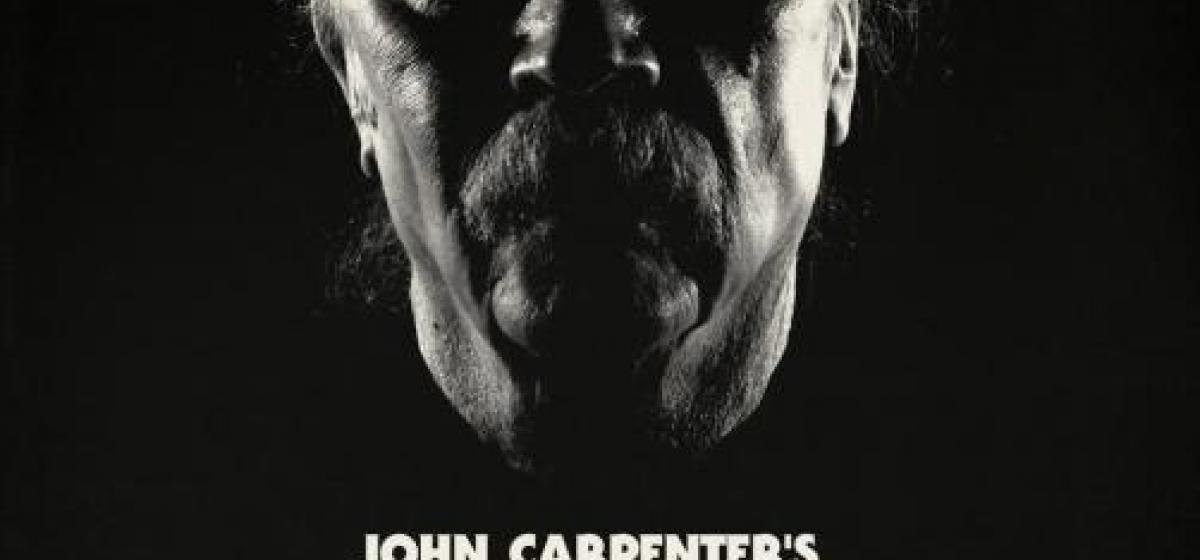Gone Girl/Fincher - Avatar fatali
Il film di Fincher è una spietata satira sul mondo dei media, dove la femme fatale è divenuta star e il delitto perfetto è quello operato dal verosimile ai danni del reale.

Oggetto filmico conturbante e attualissimo per come proietta le ossessioni noir nei vertigo dell’ecosfera mediatica. In L’amore bugiardo - Gone Girl il sogno americano si sbriciola definitivamente, dissolvendosi all’interno della patina televisiva. Ogni elemento pare disgregarsi nel suo doppio, rinviando ad una favola posticcia che termina nei territori-soap di cronenberghiana memoria.
La recessione economica, le ipocrisie dell’apparenza, i talk-show degradati in crociate anti-uomo, i reality come atti d’amore e morte, il matrimonio quale legittimazione della menzogna: David Fincher firma la sua caccia alle streghe transmediale, dove ciò che importa non è il reale ma il verosimile, costi quel che costi.
Tutte le armi della narrazione – sospensione dell’incredulità, immedesimazione, empatia – slittano all’interno dei televisivi magisteri della condanna. Il salotto tv si è autoeletto regno della giustizia, tribunale dello spettacolo cui sembra destinato il mondo intero. Bisogna essere credibili, bisogna essere amati dalla gente, bisogna saper recitare. La stessa scelta di Ben Affleck come attore protagonista si rivela vincente e programmatica nel suo significativo passaggio da attore mediocre – un uomo che non ispirerebbe alcuna fiducia – a star perfetta e remissiva che ammette i suoi peccati al cospetto dell’umanità sintonizzata.
Del resto non importa il proprio grado di colpa, ma unicamente la propria presenza telegenica. Il film di Fincher è cinico e beffardo, perché sa bene che nel 2014 ogni thriller è commedia, ogni dramma satira: se mette in scena un elemento, è subito cosciente che questo presenti un b-side, destinato ad essere rovesciato nel suo contrario. Come in un incubo di deriva mcluhaniana, il medium non è solo una nostra estensione, ma quello specchio deforme che finirà per ribaltarci e ingoiarci tutti.
In Gone Girl l’immagine vince la giustizia, in un duello all’ultimo sangue dove le apparenze e i codici della verosimiglianza hanno la meglio su qualsiasi ipotesi identitaria. Il personaggio chiave dell’avvocato, nella difesa di Nick, utilizza tutti gli strumenti che gli permettono di creare fides, di istituire consenso: è più importante lo share della verità. La tribuna, del resto, è presieduta da un giudice che tanto assomiglia a una serpe salottiera vestita alla moda, sempre pronta a iniettare veleno nel corpo del povero malcapitato di turno.
Il tema della quantità, dell’audience, del numero, veicola l’intero meccanismo narrativo, abbattendo qualsiasi ipotesi qualitativa. La verità deve piacere, persuadere, sedurre, altrimenti è una pista come tante altre, subito pronta a naufragare.
All’interno del binomio reale-verosimile, abilmente giocato con le carte della società dello spettacolo, si sviluppa l’intero film. Quinto potere incontra La guerra dei Roses, memore dei macguffin di Effetti collaterali e delle donne che vissero due volte. Ma confinare l’opera di Fincher all’ibrido postmoderno sarebbe alquanto riduttivo, perché l’intuizione più felice di Gone Girl si trova all’interno di un graduale, incontrovertibile, progetto di narrativizzazione del mondo.
Il modo migliore per comprendere quest’aspetto è focalizzarci allora sul personaggio di Amy (Rosamund Pike). Partiamo dal seguente assunto: Amy non è la fantastica Amy.
Già quest’affermazione contiene una problematica fondamentale che la rovescia epistemologicamente: per il mondo intero, Amy è la fantastica Amy. All’interno di questa radicale non corrispondenza, di questo scarto mediale, di quest’errore percettivo, si muove Gone Girl.
L’identificazione di una donna con il suo alter-ego letterario è il grado zero con cui David Fincher fa prendere le mosse alla narrazione. La fantastica Amy è infatti doppio esistenziale che agisce a livello positivo: ella è tutto ciò che Amy non è, ella ha tutto ciò che Amy sogna, ella è dunque una Amy virtuale, perfetta e mai perfettibile. Quello che Amy fa per l’intero film è portare a compimento la sua logica inventiva, coronare il sogno di rendere la sua immagine simbolo. Ecco allora che il film di David Fincher inscena la metodica costruzione di un vero e proprio avatar che fa da rivendicazione sessista: quello della donna-martire con cui rivendicare tutti gli abusi, tutti i tradimenti, tutte le malefatte del genere maschile ai danni di quello femminile. Amy scrive, intelaia una trama, progetta e narrativizza la sua intera vita per trasformarsi definitivamente nella fantastica Amy.
Per farlo ha bisogno di morire e rinascere.
All’interno di una società 2.0 il ruolo della femme fatale non poteva che essere quello della star. Amy è una scrittrice di realtà, una demiurga in grado di manipolare il reale così come costruirebbe un romanzo. Congegna un enorme what if cospargendolo di colpi di scena, rivelazioni improvvise, agendo direttamente sull’universo da lei creato. Crea verosimiglianza, fattore fondamentale in un mondo dominato dalla dittatura pubblica. Architetta, giorno dopo giorno, un romanzo transmediale, ben cosciente di come il consenso sia restituito dall’apparenza e non dalla legge stessa. L’obiettivo, vincente, è uno solo: creare una storia che seduca l’America.
La televisione, la radio, i social network, i siti internet sono gli strumenti per un diabolico, baudrillardiano delitto perfetto. La vera perdente nel film è la verità, che viene umiliata, derisa, accantonata, e dunque sostituita dai propri simulacri. Il mondo desidera donne incinte, capri espiatori, uomini vendicativi e crudeli, riscatti e rinascite, riconciliazioni e mogli che, nonostante tutto, vivono due volte.
In fondo Amy regala al pubblico una forma sinestetica di storytelling, completamente al passo con i tempi. Fincher la segue pedissequamente, permettendosi flashback inventati, cambi di punti di vista, colpi di scena moltiplicati, fino a raggiungere il geniale parossismo di un film che si commenta da solo (Ben Affleck in macchina, borbottante, lancia una sfida allo stesso script: “Ti sfido Amy. Torna a casa”).
Amy allontana la monotonia, crea un testo-game come fossimo in un film di Hitchcock che agisce a livello esponenziale. Eppure, proprio lei, cade nell’errore di sottovalutare la stessa materia narrativa, di non prevedere eventuali, effimere falle all’interno del suo piano. Si ritrova così inizialmente vittima della sua medesima creazione. Chiunque padroneggi un universo mediatico non dovrebbe mai dimenticare che il medium ha una capacità vicariale. I rapporti di potere vengono ribaltati poiché qualsiasi forma mediatica è instabile, imprevedibile e completamente ingestibile. Si pensi a tutta la letteratura e la cinematografia che ruotano intorno al tema dell’errore quale emancipazione, condanna, liberazione da un sistema chiuso e transitivo: la prostata asimmetrica di Gone Girl è ovviamente il caso, l’inatteso, che ribalta i piani della protagonista.
Amy stessa si troverà incastrata all’interno di una lussuosa prigione di telecamere: è ironico osservare come sia proprio lei, architetto di realtà virtuali, a trovarsi in trappola in un reality show esemplare. Eppure colei che è spiata, colei che è sul punto di affondare, si scopre la concorrente più geniale. Il reality si macchia di sangue e la nostra fantastica Amy ribalta la situazione, rovesciandosi in geniale manipolatrice che uccide per vincere (che uccide per amare, dirà lei).
Ritorna a casa, come una Carrie contemporanea, priva di poteri magici ma ricca di virtù mediatiche, e regala al mondo l’happy end di un matrimonio patinato e felice, in una casetta perfetta che sembra costruita appositamente per il truman show. La fantastica Amy ha lottato contro gli orrori del mondo ed è tornata più forte che mai, pronta a rinascere e dare nuova vita.
Tutto il finale del film è luccicante, algido e fintissimo: quasi un nuovo reality basato su una convivenza improbabile. Una moglie omicida e sociopatica, un marito infedele che la odia, un nuovo bimbo all’orizzonte: roba da sitcom! Le mura della casa, ennesimo interno che si vorrebbe confortevole, pullulano di forze negative, di orrori taciuti, di spettri quotidiani, nascosti dai mille sorrisi di convenienza. “Si chiama matrimonio” commenterà causticamente Amy.
E’ bene soffermarsi sull’immagine di Amy e Nick che scendono dalle scale, in attesa di parlare in tv. Sembrano redivivi pronti a tornare in scena, in attesa di mostrare le finte meraviglie della loro relazione rinvigorita. Lei, novella Norma Desmond, che ha bisogno di essere amata e sa bene che è sempre stata grande ed è il mondo a esser troppo piccolo. Lui, Truman che non è mai fuggito, marionetta virtuale priva di vita, barzelletta domenicale del marito infedele ormai pentito.L’immagine di Nick e Amy ha finito per vincere e uccidere gli originali. Ancora una volta la copia deforme li ha pervertiti, gli ha fatto compiere azioni terribili, li ha resi irriconoscibili l’uno di fronte all’altro. Qualsiasi gesto, atto o movimento che i due possano fare, li sdoppia e li rilancia in un labirinto senza fine.
L’incubo gretto ma saldissimo della società delle immagini si trasfigura nell’edificazione perversa di una riconciliazione fasulla. Il soggetto, fratto, estatico, posseduto, ha perso ormai qualsiasi ipotesi identitaria, per trasformarsi in un marito – o in una moglie – che può lanciare il suo smack all’interno di una nuova, fatata casa di bambole. E con quel bacio che non c’è, l’avatar ha investito il matrimonio, i rapporti sociali, i riti comunitari, gli stessi sentimenti umani, senza concedere alcuna possibilità redentiva. Come quella bionda spirale di capelli sembra ricordarci, tutto è successo già due volte, il mostro è il medium stesso.