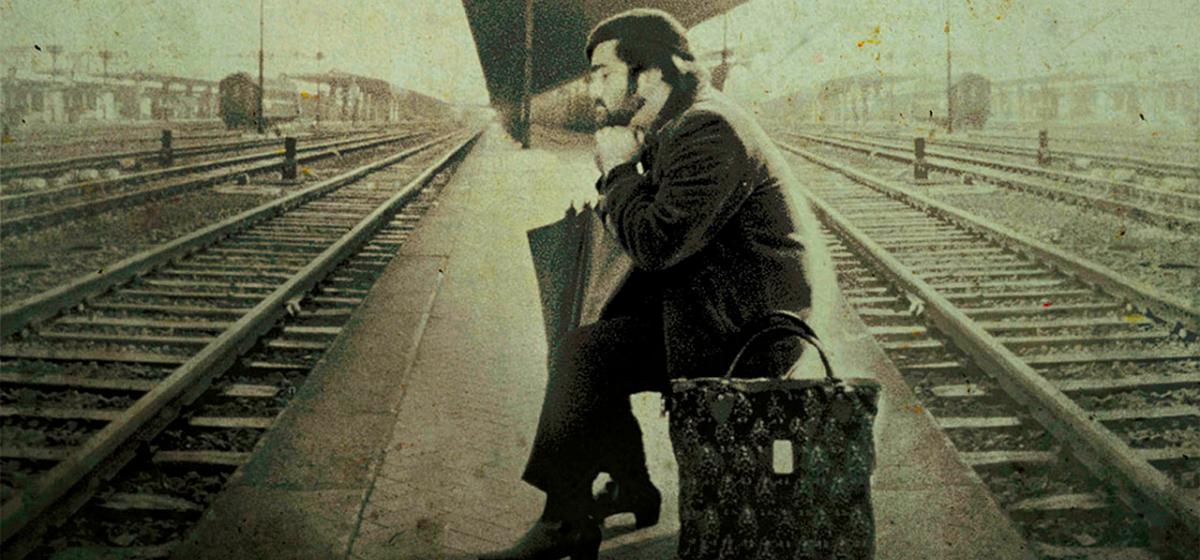Cinema Grattacielo
Architettura grandiosa e futuribile, utopia di un mondo nuovo, fantasma di un sogno interrotto: il grattacielo di Rimini raccontato con fantasiosa e visionaria empatia.

Ci sono architetture che parlano un linguaggio simbolico che muta di segno nel corso del tempo, facendosi specchio dell’evolversi della realtà sociale e culturale che le ha prodotte. Architetture magiche che sono il luogo di condensazione di sogni e immaginari collettivi, della loro travolgente potenza come della loro terribile fragilità. Il grattacielo di Rimini è una di queste: fantasma immenso e malinconico che si impone allo sguardo per la sua mole e la sua altezza, è forse tutto quel che resta del mito balneare della Riviera Adriatica, a ricordarci l’ingenuo ottimismo e le speranze disattese del boom economico degli anni Sessanta. Agli occhi di molti, in questo presente nero di precariato, disillusioni e croniche incertezze, non è che un ecomostro fatiscente, un pugno nell’occhio che spezza e sporca l’orizzonte azzurro e quieto del mare. Ma per chi ha, invece, gli occhi di un poeta, è piuttosto un monolite misterioso e arcano, una torre di Babele ancora pulsante di vita, uno spettacolare monumento a quei sogni interrotti – l’utopia del benessere della “società del non-lavoro” – con cui tutt’oggi stiamo facendo i conti. E ancora: è un organismo senziente e pensante, che parla, ricorda e racconta con la voce mite e carezzevole dello scrittore Ermanno Cavazzoni. Lo sguardo altrui, perplesso, quasi offeso, gli ricorda costantemente la sua natura aliena, la sua dolorosa inconciliabilità con il paesaggio.
Ma, per fortuna, c’è anche chi lo ama e lo difende: i suoi abitanti, una comunità multietnica variegata e vivace che non ha niente a che vedere con la ricca e pigra borghesia vacanziera per la quale era stato progettato, e che anima quotidianamente i suoi spazi labirintici saturandolo di odori e rumori. Un operario del Senegal genio del calcio, una donna incinta che si accarezza la pancia e canta una ninna nanna, un’urbanista che immagina un teatro al piano terra, due gemelli identici che guardano il panorama dalla finestra, un attore che vive con il suo compagno e un gatto, un’anziana innamorata della pelliccia che indossa, una processione di monaci tibetani e perfino un ghepardo che sfreccia all’improvviso nel corridoio, spaesante visione felliniana. Tra di loro, il regista Marco Bertozzi, che forse – chissà – ha scelto il grattacielo proprio perché, in virtù della sua esasperata verticalità, offre a chi lo abita una relazione speciale e privilegiata con l’atto del guardare, e ogni giorno inquadra nelle sue infinite finestre-schermo innumerevoli gamme di azzurri, grigi e indaco fatti di acqua, brume e nuvole: spazi sconfinati e quasi astratti, deputati al volo caotico degli uccelli, prestati alla presenza umana solo in virtù dell’altezza vertiginosa di questa buffa e sproporzionata architettura.
Non viene in mente un approccio migliore di quello adottato da Bertozzi per raccontare l’anima dolce di questo goffo e malandato colosso di vetro e cemento: un cinema morbido e sfaldato, permeabile, frammentario, liquido, che restituisce assieme all’oggetto film anche il suo processo di lavorazione sempre aperto all’imprevisto (con osservazioni fuori campo che creano cortocircuiti temporali, sollevano dubbi e aprono possibilità). Mettendo in discussione il linguaggio del cinema nel suo farsi, il regista scava nelle memorie private della sua infanzia ricucendole a quelle collettive della nazione, racconta un passato e un presente che prendono forma in un doppio sguardo: quello dal basso – inevitabilmente stupito e disorientato - sul grattacielo e quello dall’alto – ampio, limpido, potente - del grattacielo stesso. E se è vero che il grattacielo è già, ontologicamente, cinema – perché le file di finestre sono strisce di pellicola, perché ogni sua finestra aperta è un campo lungo – Cinema Grattacielo è una dichiarazione d’amore per questo gigante vecchio e solitario, accarezzato dal rumore del mare e corteggiato dalla luna, una poesia naïve per questa architettura impossibile e smisurata come il sogno che l’ha prodotta.