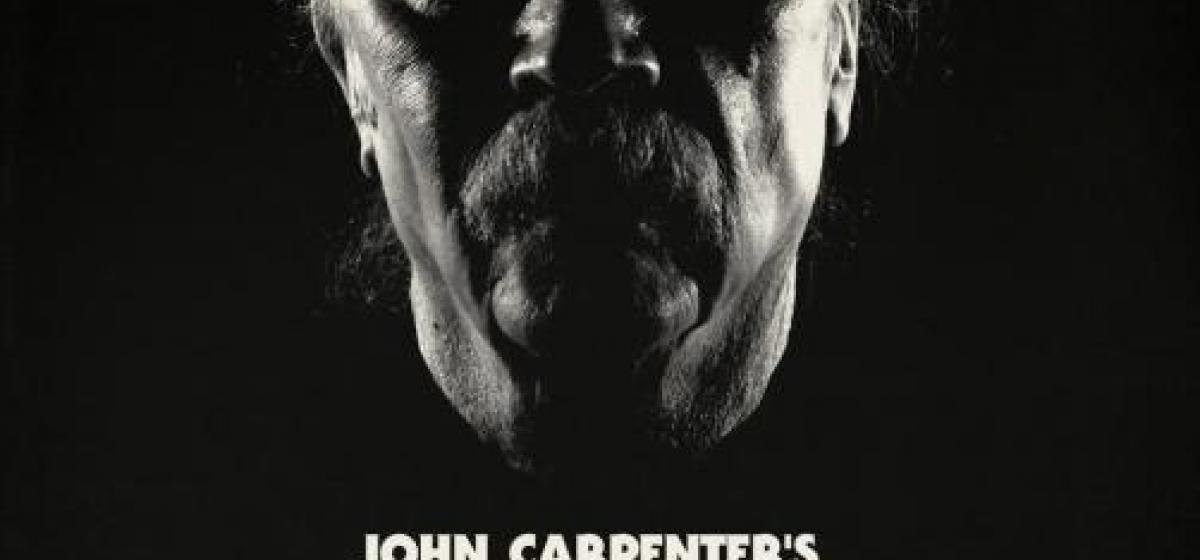Vizio di forma - Dal petrolio all'Acquario
Ovvero di come il cinema di Paul Thomas Anderson esplori il Novecento USA all’inseguimento disperato di un’altra America.

Dalla ricerca del petrolio all’era dell’Acquario, dalla chiesa della terza rivelazione all’avvento del videotape, dalla seconda guerra mondiale al conflitto in Vietnam, dalle trivelle che portano soldi ai bigliettoni a palate di Dirk Diggler, dalle foglie di marijuana alle sniffate di cocaina, e tutto a un tratto siamo già negli anni ottanta.
Quattro titoli per quattro americhe: gli albori imprenditoriali del Novecento (Il petroliere), le fragili superfici degli anni cinquanta (The Master), le isole di luce di surfers e hippies (Vizio di forma), la dissoluzione di un intero mondo convertito in videotape (Boogie Nights).
Risulta subito chiaro come Paul Thomas Anderson, uno dei più grandi narratori americani contemporanei, sia segnato dall’ambizione sconfinata di ricostruire, riscrivere, riesplorare la storia americana novecentesca, per scovarne una singolare antologia del potere.
Si consideri ogni suo oggetto filmico alla stregua di un vastissimo ipertesto in grado di problematizzare qualsiasi postmodernismo d’accatto. Un cinema che non è mai banalmente citazionista, non si serve di totem o feticci, non museifica né sprofonda nella furia iconoclasta, ma intelaia una scrittura filmica che è prima di tutto una questione fisica. L’approccio di Anderson alla Storia è quello di chi tocca sempre per mano i propri personaggi, di chi si immerge letteralmente all’interno della materia trattata, di chi vanifica la sterile fiumana di parole che pur lo avvolge, alla ricerca, forse, di un’altra America.
I primi venti minuti de Il Petroliere sono il punto alfa ideale del suo cinema. Avulsi a ogni tipo di logocentrismo, affondano nella fatica fisica, nel lavorio continuo e insaziabile, nel sudore e nell’affanno del sottosuolo. Il germe iniziatico del capitalismo deve essere intercettato nelle profondità della terra.
Continui colpi di piccozza si alternano alle percosse di un martello che spinge un paletto nella roccia. Un corpo solitario, al servizio di un sogno, continua a scavare di giorno e di notte, come posseduto dalla febbre dell’oro.
Daniel Plainview è l’autentico self-made man del sogno americano, l’ombra irrequieta che si nasconde dietro alla maggior parte dei personaggi andersoniani. Muscoli tesi, grugniti ferini e fervore estatico, inebriati da piogge di terra e fango. Daniel consuma energie inesauribili, si rompe perfino una gamba, eppure continua ostinato a scavare, come se il suo corpo non fosse progettato per fare altro che trivellare la terra. Diventerà un vero e proprio magnate, simbolo per eccellenza di un arrivismo smodato, anima brutale in grado di forgiare dal nulla un vero e proprio impero economico.
Per fondare la sua riflessione sulle radici americane, l’immagine-emblema del volto mefistofelico di Daniel al cospetto della sua gargantuesca conquista, diviene il perno di un’intera filmografia. L’esplosione di un pozzo di petrolio assume la dimensione sacra di una rivelazione perversa, di una dannazione ad vitam, quasi una grazia capovolta. Gli occhi, accesi da un’epifania di luce, custodiscono una potenza infinita.
Il Vangelo made in USA si rivela intriso di violenza, possessione, concupiscenza e dominio pulsionale dell’altro.
Il cinema di Anderson, del resto, è da sempre interessato ai meccanismi di potere, alla brama di controllo, alla ricerca abnorme di un acquiescenza condivisa. Daniel dovrà ottenere consenso e fiducia per poter trivellare terre altrui. La base stessa del consenso è lo strumento indispensabile per poter esercitare un potere eminentemente politico. E se l’arrivista novecentesco è prima di tutto un corpo politico, dev’essere austero, rispettabile ma disponibile, violento ma gentile, come i codici machiavellici insegnano da secoli.
Daniel Plainview, assetato di sangue e potere, troverà la sua nemesi in Eli Sunday, capo della chiesa della terza rivelazione. Lo scontro iniziatico, perno del pensiero andersoniano, è allora tra due Americhe, tra due corpi istituzionali, tra due profeti (o falsi profeti) che, paradossalmente, si riconoscono l’uno nell’altro. Il corpo capitalista e quello evangelico che, nella disamina del regista, sono figli della stessa grande madre: quella nazione forgiata nel sangue e nel mito, che vive di rimpianti storici che nulla potrà cancellare.
Il conflitto finale trova il suo set perfetto in una sala da bowling, dove il corpo animalesco di Daniel divora quello di Eli, per poi cadere a terra sfinito. Il corpo politico uccide quello evangelico per legittimare la sua stessa potenza. Diviene assassino solo dopo aver sfruttato pubblicamente l’altro, allo scopo di ottenere consenso. La violenza è lo strumento stesso per perpetuare l’esercizio del potere.
Questa sorta di capitolo zero della filmografia andersoniana ci restituisce le coordinate per poter comprendere meglio le due anime complementari che abitano questo cinema. Le pellicole di Anderson raramente si rifugiano nell’uno, ma si sdoppiano, cercando nell’altro la conferma della propria stessa identità. Si potrebbe parlare di una vera e propria ossessione del regista per la dialettica uomo-uomo, per la coppia, per gli opposti che si attraggono e si rivelano un tutt’uno. L’altro non è l’eccedenza ma il veicolo con cui poter costruire se stessi: tutti gli (anti)eroi di Anderson sono consapevoli del fatto che senza l’altro non esisterebbero.
Dalle coreografie corali di Magnolia ai set a luci rosse di Boogie Nights, l’America si configura come una cerchia infinita di individualisti che hanno una paura fottuta di rimanere soli. Non a caso, quando i personaggi perdono tutto, incominciano a rimpiangere un’alterità che hanno scacciato, respinto, perfino odiato. Si pensi alla costante andersoniana dei rapporti padre-figlio che, passata in rassegna, identifica nel rimpianto il vero protagonista di questo cinema. Proprio come il ventesimo secolo americano, l’epoca della lacrima che segue la bomba.
Quest’opposizione, questo conflitto individuo-individuo, brilla di luce propria in The Master.
All’interno di un film-cervello, crocevia delle forze psichiche e dei campi fisici che imperversavano nell’America degli anni cinquanta, assistiamo a quella che prima di tutto è un’intensa, fragilissima storia d’amore. Anche qui il regista prende due figure e le trasforma in archetipi, visioni del mondo, forme cardinali. Questi archetipi originari sono ovviamente il Padre e il Figlio, il Maestro e l’Allievo, il Padrone e il Servo.
Freddie Quell è un reduce fisicamente e mentalmente provato dagli orrori della seconda guerra mondiale. La sua camminata, il suo modo di parlare, la sua stessa visione del mondo, sono figlie di un’intera generazione di reduci traumatizzati, ancora più che dalla guerra, dal rientro a casa. Impossibilitati a ritrovare una normalità che li ha dimenticati, si agitano come corpi inani e vuoti invasi da tic e nevrosi di ogni tipo. Errano senza una meta, vivendo tra i ricordi e i fantasmi di una vita lontana. La loro stessa fragilità è accentuata da un paese aperto a nuove prospettive che si susseguono a velocità insondabili. Questi reduci sono degli scarti troppo lenti per riadattarsi, dei residui da cancellare, dei resti da omettere. Sono la cenere di un paese che vuole guardare avanti. Proprio per questo si rivelano corpi perfetti per essere riprogrammati ex nihilo.
The Master indaga sul sistema nervoso di un’intera nazione, ma soprattutto sulle strategie di un potere che per affermarsi ha bisogno di sedurre mediante il verbo. Lancaster Dodd, guru di un’altra terza rivelazione, utilizza la parola per adescare l’altro. La violenza che alimenta il corpo convulso di Freddie dev’essere incanalata all’interno di forme socialmente condivise, ma mai rimossa. La parola di Dodd è sempre parola di potenza: infiamma e commuove, rapisce e distrugge. Ma quest’ennesimo Maestro, meno viscido ma altrettanto persuasivo del Frank Mackie di Magnolia, scoprirà nell’allievo un nuovo figlio da poter modellare, istruire, perfino amare, a proprio piacimento. Il discepolo è dunque un vuoto da riempire.
Il lavaggio del cervello operato da Dodd è una forma d’istruzione che fa rima con la relazione paterna, ma prevede sempre una dialettica servo-padrone. Questa dialettica evita facili schematismi, ben consapevole che non esista padre senza figlio, né maestro senza allievo. La sopraffazione diviene allora relazione d’amore, dipendenza reciproca. Quando Freddie riuscirà a sfuggire dalle grinfie del padrone, alle languide e sofferte richieste del suo messia, risponderà “Magari in un’altra vita”. All’interno di questa frase, Anderson rilancia ciclicamente uno dei temi fondanti del suo cinema: l’impossibilità di una vera, autentica libertà, se non in squarci trasognanti, passaggi segreti bellissimi che conducono verso un’altra, invisibile America: l’immagine emblematica di Freddie che, a bordo di una moto, svanisce nel deserto. L’unico terreno possibile in cui ritrovare quella libertà tanto agognata è allora quello della fata morgana: il cinema, l’illusione, il sogno.
Dalle vagine di sabbia cui farà ritorno Quell alla pioggia di rane di Magnolia che tanto somiglia a una catarsi collettiva. Dalle miglia aeree di Billy (Ubriaco d’amore) al finale chimerico e dolcissimo di Vizio di forma.
Doc Sportello, infatti, si rintanerà nel cinema, nel mito, nell’immobilità del ricordo, consapevole che il suo è un paese che cambia troppo in fretta. Il detective hippy e strafatto, che vive, lavora e si mette nei guai per amore, è ormai fuori posto.
Vizio di forma canta la California dei primi anni ’70, tenendo assieme, in un unico abbraccio, l’epoca delle controculture americane con la sensazione irredimibile che qualcosa stesse cambiando per sempre. Hippies, surfers, bande di motociclisti, spettri delle stragi Manson a ogni svolta narrativa. Più che un film, più che un libro, Vizio di forma pare una costellazione in grado di far rivivere l’immaginario americano di una generazione.
Adottando insospettabilmente i codici del noir metafisico anni ’40, sembra quasi che l’intero film sia una gigantesca, rocambolesca allucinazione di Doc Sportello. Ogni cosa assume connotati spettrali, sprofondando all’interno di un complicatissimo caso-caos. Nel suo rimodellare il romanzo pynchoniano, l’autore acquisisce una malinconia fuori dal tempo, un rimpianto per un’epoca dissolta nella memoria nazionale.
In totale controtendenza con il postmodernismo più cinico cui siamo abituati, il Doc Sportello di Anderson è un personaggio umano, troppo umano. Quando il mondo gli sfugge di mano, quando lo squallore e la violenza stordiscono tutto ciò che lo circonda, lui diventerà fantasma tra i fantasmi: il finale del film è da leggere come un ritorno a quell’isola di luce che l’America avrebbe spazzato via negli anni seguenti. Doc ci guarda, in un’inquadratura che è un atto d’amore infinito nei confronti dei noir che si accendono e spengono nella mente. Anche lui è destinato a scomparire, eppure rimarrà sempre lì, perché tutto ciò che è perduto vive da fantasma. Questo è il terreno altro in cui si muove il film, l’immaginario di chi sapeva amare perfino al dilagare della paranoia.
Eppure le cose sono cambiate. Alla marijuana si sarebbe sostituita la cocaina di Boogie Nights.
Nel film che lo lanciò al grande pubblico dopo l’esordio Sidney, si racconta l’industria del cinema a luci rosse americano, a cavallo tra gli anni ’70 e gli ’80. Il set cinematografico diviene una famiglia espansa, punto di vista privilegiato per assistere a un declino che non avrebbe risparmiato nessuno. Questa decadenza, genialmente esemplificata nel passaggio dalla pellicola al videotape, racconta la dissoluzione del mito, la caduta degli eroi, il miraggio del potere e del successo, l’intossicazione bulimica di un’intera società. Ma, lucidamente, ci dice anche che le immagini, sempre più forti, sempre più numerose, hanno generato un terribile oblio, quello della nostra stessa identità. I protagonisti di Boogie Nights sono costretti a piegarsi alle logiche del mercato imperante. In un mondo che va verso la bassa definizione, rimangono i ricordi, gli affetti, i rimpianti e il desiderio dolente di annebbiarsi la mente, di lasciare che tutto avvenga, di gettarsi in un sonno lungo una vita. Perché già all’inizio della propria carriera, al ritmo di petardi che sembrano spari, Paul Thomas Anderson sapeva che non si poteva più tornare indietro. Quell’altra America, che tanto bramano i suoi personaggi, era forse il sogno deforme di Doc Sportello, sdraiato sul letto, strafatto d’erba e, per sempre, ubriaco d’amore.