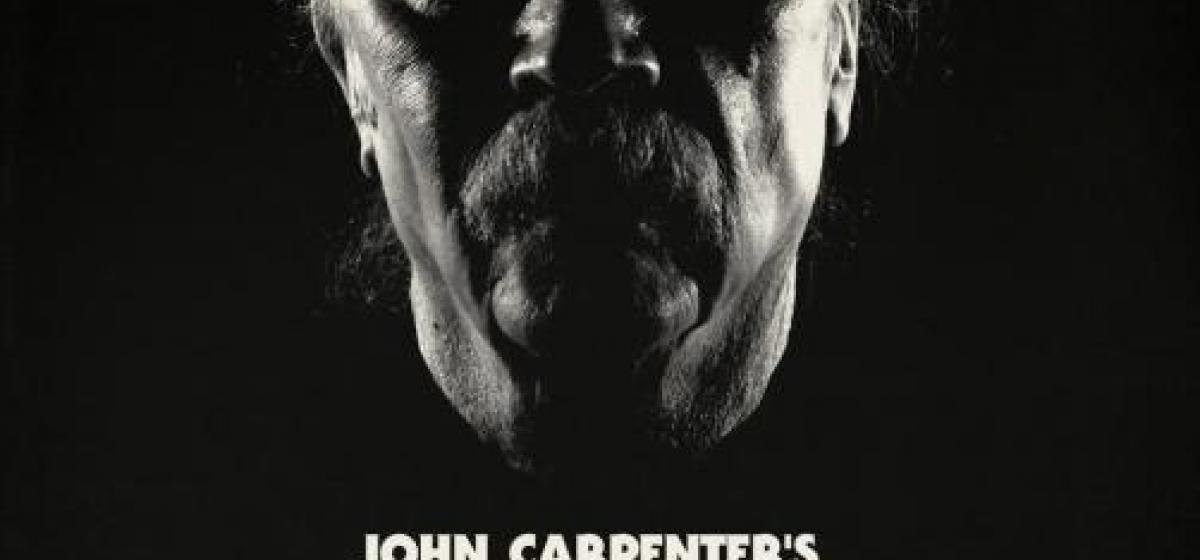Per una volta mi trovo costretto a infrangere la regola della distanza critica: risulta impossibile scrivere di Maps to the Stars senza usare la prima persona. Si tratta di un’opera troppo articolata per essere vivisezionata dopo un’unica visione, per non attrarre un intero universo di segni che rimanda, inevitabilmente, ad altro. Per uscire dall’afasia – effetto paradossale dopo un film parlatissimo – mi sono chiesto a lungo quale fosse il modo migliore per cominciare. Mi sono reso conto che avevo bisogno di tornare alla visione stessa, alle prime impressioni azionate durante il flusso del film. Mentre un mondo di parole avvolgeva la sala, appuntavo cifre, dialoghi, sensazioni immediate non filtrate da rielaborazione alcuna. E’ come se all’interno di un film dove, inevitabilmente, non c’è film o c’è troppo film, in assenza vertiginosa di un centro, avessi avuto bisogno di costruire – inconsciamente e ironicamente – una mia personale mappa, una sorta di bussola orientativa che mi guidasse tra le immagini.
1. Mappa personale e/o bussola per le stelle.
Soap-opera putrefatta - sembra di assistere a un melò congelato. L’artificiale ha vinto, ma questo era già successo (basta pensare alle altre mutazioni cronenberghiane, agli eXistenZ e ai Videodrome per non parlare di Tsukamoto, dell’Holy Motors di Carax, dell’ultimo Korine ecc).
L’immaginario contemporaneo solidificato in un freezer: come si esce dalla stasi?
Nessun presente - verità dei fantasmi (unica realtà quella del passato? Che cos’è allora questo passato? Quanto ha a che fare con le nostre categorie interiori?).
Fantasmi* (il problema dell’asterisco è che non si ricollega a nulla all’interno dei miei fogli. Ma, a memoria, doveva riportare la mia attenzione nei territori del doppio di A History of Violence)
NO POV (dove POV sta per Point of View) – chi sta giocando al videogame? Non c’è nessun joystick e il mondo non è più osservato da una limousine. Mancano gli occhi di chi guarda, ma tutti sono sempre e comunque guardati. Manca il soggetto.
Natura pretestuosa narrazione/personaggi/relazioni umane – React/Remeake/Revivre,
Da approfondire: David Cronenberg ha girato un film sul pretesto (inteso, ovviamente, anche come pre-testo: così l’idea di sceneggiatura che Agatha racconta a Jerome Fontana, l’autista di limousine. Quell’idea si rivelerà il film stesso girato da Cronenberg).
E poi una domanda: Il destino dei personaggi di Cronenberg è forse il mito? cui segue la provocazione indiscreta di un amico: E se il prossimo film di Cronenberg fosse una tragedia di Shakespeare?. Ultima parola degli appunti: postproduzione.
2. Quale geografia?
Ora bisogna provare a rimettere insieme i pezzi.
Abbiamo parlato di mappe perché tutto il mondo possa esserne contenuto. Ma di che geografia stiamo parlando? Dove siamo? A Hollywood, così pare, ma risulta subito riduttivo dire che Maps to the Stars sia un film su Hollywood. Lo è nella dimensione in cui è la città iconica di stelle, angeli e meteore. Stelle come star ma anche come diamanti del cielo, mai inquadrate in presa reale ma sostituite da un loro simulacro spettrale, da un loro doppio umbratile e postprodotto. Ecco perché prima ancora di essere un film su Hollywood, Maps to the Stars si rivela un film sulla postproduzione del reale. Dimenticate il virtuale, è una parola vecchia, dall’eco tristemente démodé: il fatto stesso che la realtà del film abbia smesso di proclamarsi virtuale segna la totale vittoria della simulazione, la sconfitta su tutti i fronti dell’umanità. Siamo arrivati al livello che basta parlare di realtà per sottintendere, strutturalmente, la virtualità. Ma che cos’è allora la città degli angeli, dove si muovono i modelli del film? “Quando non c’è più territorio vergine, e dunque disponibile per l’immaginario, quando la carta copre tutto il territorio, qualcosa come il principio di realtà scompare” scriveva Jean Baudrillard. In questa totale, maniacale organizzazione del territorio, dove tutto è palesemente ipercodificato, schiavo della sua stessa perfezione luccicante, l’idea è che a scomparire sia l’intero mondo esterno. La confusione tra vivi e morti è parte integrante di ciò che rimane del vigente: uno sberleffo alla ragione, un melting pot tra terra e oltretomba, sotto la lente di una soap deforme e mostruosa. Ma per arrivare a questo punto serve fare un passo indietro e ricostruire, pezzo dopo pezzo, quella storia di un’infezione che è il cinema tutto di David Cronenberg.
3. Quale storia?
“Il concetto di archetipo, che è un indispensabile correlato dell’idea d’inconscio collettivo, indica l’esistenza nella psiche di forme determinate che sembrano essere presenti sempre e dovunque”.
(Carl Gustav Jung, Il concetto di inconscio collettivo)
Ancora una volta il singolo pezzo del progetto-Cronenberg si rivela parte di un corpo più grande, che, di organo in organo, eccede se stesso, scopre nuove protesi e arti ulteriori: cinema multiforme sempre pronto a cambiar pelle. In questa storia del contagio non serve sottolineare ciò che è sotto gli occhi di tutti, il fatto che David Cronenberg sia sempre stato il regista della viralità: si tratta dell’uomo che ha inscenato il potere narcotico della tecnologia, identificando nella regressione e nel sonno della ragione la promessa della nuova carne. Il medium necessario per il contagio fu, in origine, il corpo. Complice il fascino delle interiora e la profezia della rigenerazione, da Il demone sotto la pelle a eXistenZ passando per Videodrome e La mosca, il corpo è sempre stato il veicolo della mutazione, dove era l’errore umano – la prostata asimmetrica potremmo dire – l’unica ancora di salvezza, l’unica possibilità di humanitas in un mondo che ne era privo. Poi è cambiato qualcosa: i nuovi orizzonti palesati dalla rete, la proliferazione delle informazioni, le strategie di comunicazione del nulla, la cultura convergente col suo accumulo sinestetico/sintetico hanno spezzato un equilibrio già precario. La cellula cancerogena, aperta alle infinite possibilità del cervello, ha esteso il suo dominio con una serie ipertrofica di metastasi che gli hanno permesso di arrivare alla mente (Spider) con il risultato di sdoppiarne l’identità (A History of Violence).
Non c’è stato un autentico cambiamento nel cinema dell’autore, per cui non ha mai avuto senso parlare di un primo e di un secondo Cronenberg. Ciò che è cambiato è il medium: il virus non poteva fermarsi al corpo, doveva avanzare. Si è rivelato allora necessario fare un passo indietro, scavare nel proprio cinema, capire da dove provenissero i demoni sotto la pelle, ricercarne le origini e i prodromi culturali. Per farlo era necessario eliminare qualsiasi potenza visionaria, cadere nell’eleganza del costume e ritornare alla base intellettuale del pensiero novecentesco. Era necessario ripartire dalla psicanalisi, costruire un prequel ideale di gemelli inseparabili, un’originaria zona morta dell’immaginario. A Dangerous Method si pone in rilievo dunque come il punto di svolta del processo cronenberghiano, quello che segna l’epocale passaggio di medium: dal corpo al verbo, dall’organo alla parola. Di qui in avanti i personaggi del suo cinema sono continuamente parlati, non esistono se non in funzione del verbo. Si è passati, in un momento, dalla dimensione patica, grezza della carne a quella intellettuale, vana, scientifica del logos. Parlare significa decodificare, analizzare, tentare di poter spiegare un mondo che rifiuta se stesso. Riuscire, infine, nell’impresa più folle e ardita: la possibilità di mappare la mente, di indagare un impero (quello mnemonico), di decodificare strutture interiori, di rendere, a tutti gli effetti, l’uomo materiale narrativo. E’ questo il metodo pericoloso del titolo: che le realtà interne, così come i loro riflessi sfumati (il mondo) divenissero funzioni narrative, punti nodali che permettessero un più alto grado di conoscenza. Freud e Jung si configurano dunque come le due anime della filmografia di Cronenberg, le basi necessarie del suo pensiero. Si potrebbe addirittura affermare che il grande contagio inscenato da Cronenberg trovi il suo momento auratico in un fatto storico irripetibile. In viaggio per gli Stati Uniti Freud si rivolge a Jung: “Non sanno che stiamo per portare la peste”. In quello stesso momento qualcosa si è spezzato e i demoni del rimosso (i fantasmi dell’inconscio) sono emersi dall’oscurità.
Dopo questo necessario punto zero David Cronenberg è stato libero di tornare al presente per finire a domandarsi, quale presente? Cosmopolis è il prodotto esemplare scaturito da questa verbalizzazione del mondo. La parola-mondo si è ovattata e rinchiusa all’interno di una limousine che avanza come un ventre materno e metallico, punto di vista privilegiato per un presente dominato dal nulla economico.
4. Soap perversa: il problema dello spazio e il tema della traccia
“Tutto il mondo ha coscienza che la vita è parodistica e che manca una interpretazione. Così il piombo è la parodia dell’oro. L’aria è la parodia dell’acqua. Il cervello è la parodia dell’equatore. Il coito è la parodia del delitto”.
(Georges Bataille, L’ano solare)
Maps to the Stars apparentemente si struttura come l’antitesi di Cosmopolis. Se quest’ultimo, infatti, era un kammerspiel virtuale, Maps to the Stars è forse l’opera più luminosa del regista, così assolata da bruciare, tutta proiettata in un en plein air asfittico come mai. La lussuosa villa in cui vive la famiglia Weiss non appare più come il rifugio intimo dal mondo, ma è cosa tra le cose, materia pubblica, dimentica della differenza tra esterno e interno: non più muri ma vetri con la conseguenza che tutti possano vedere tutto.
I Weiss d’altronde vivono sotto il segno dell’apparenza: Benjamin è il classico ragazzino prodigio di Hollywood, la madre si prende cura della sua carriera, il padre è un terapista sui generis. L’immagine – la loro immagine – è tutto. Proprio per questo hanno dovuto cacciare Agatha, la figlia piromane, l’elemento d’instabilità all’interno del quadretto famigliare perfetto. Ma quest’apparenza non è riducibile alle superfici glamour di The Bling Ring, alla morte della privacy di The Canyons, alla menzogna dei rapporti umani di Effetti collaterali. Tutti questi film assumono il ruolo (consapevole o meno, non ha importanza) di codice geografico-morale volto a localizzare la morte del sentimento. Eppure, malgrado tutto, si ha la contraddittoria sensazione che Maps to the Stars non conosca esterni: sembra quasi che la limousine di Eric Packer sia finalmente esplosa, e quel mondo ovattato si sia aperto cospargendo le sue tracce ovunque. Ironicamente tutta Los Angeles pare costretta in una limousine, e ogni esterno sembra in realtà un grande, elaborato interno. Canyons di Hollywood, starlette viziate, famiglie disfunzionali e, ovviamente, un mondo di psicofarmaci: come Cosmopolis era il film che arrivava dopo la fine ma presentava ancora imperfezioni organiche (la prostata asimmetrica), Maps to the Stars si colloca dopo il cinema tutto di Cronenberg. Il problema è proprio questo: il virus c’è già stato, ha ormai contaminato il mondo, ma tutti se ne sono dimenticati. E’ come se ogni mutazione del corpo si fosse sedimentata in funzione di traccia, di residuo, di segno corporale: così il volto parzialmente ustionato del personaggio di Agatha. Non è più tempo di trasformazioni ipodermiche, ma di retaggi e di eredità accumulate.
Se la mutazione s’identifica con la postproduzione di se stessi, le relazioni sociali fungono da algoritmo perfetto per una nuova carne posticcia e artificiosa. L’unico linguaggio per smascherarla è quello della satira e del grottesco, perché l’orrore non è più quello che spaventa ma quello che fa ridere. Riguardo all’effetto-ridicolo mi riaggancio alla stroncatura del film a opera di Nicholas Barber per la BBC: “Niente in Maps to the stars sembra avere importanza. I fantasmi non spaventano, la violenza non preoccupa, gli scherzi non fanno ridere”. Paradossalmente sono proprio le sue parole a rendere conto del carattere peculiare e straordinario del film. Stroncarlo per questi motivi significa, in realtà, centrare il punto e sottolineare una notevole coerenza strutturale, una passività di fondo che troverà il suo fulcro proprio nella dimensione del rimosso. Perché non dimentichiamo come Maps to the Stars sia, prima di tutto, un film sui fantasmi.
(continua…)