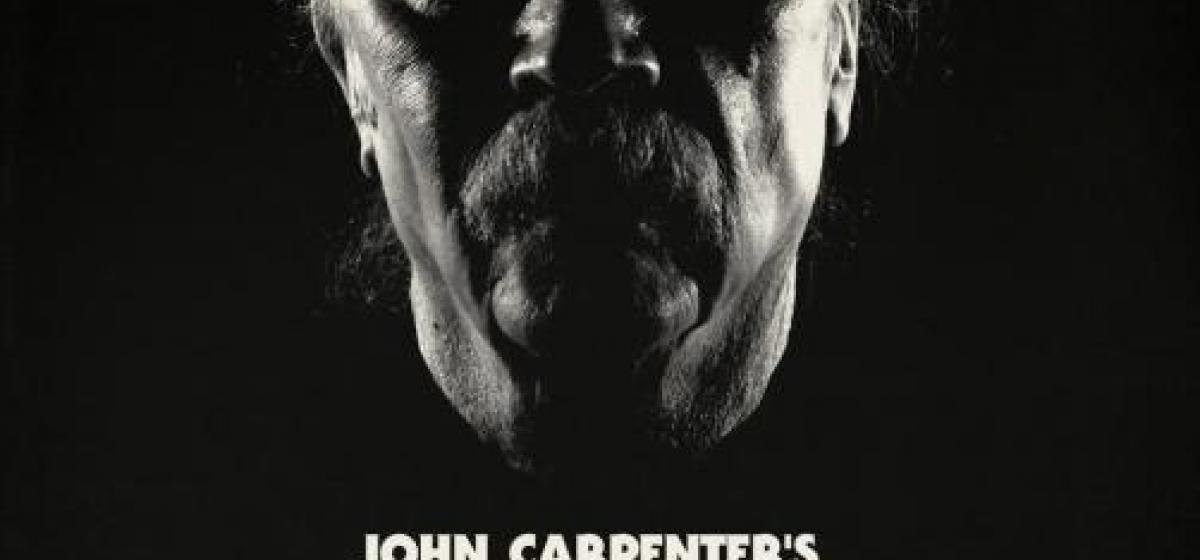Blackhat / Michael Mann - Cinema (post)organico
Cosa fa dell'autore di Blackhat il cineasta hollywoodiano cruciale del nuovo millennio.

Dopo aver scritto mezza vita fa un libro su Michael Mann, ho continuato con costanza a chiedermi perché il suo cinema è cruciale, ora più che mai, cosa lo rende insostituibile: qual’è il suo touch, si sarebbe detto all’epoca della classicità lubitschiana; la sua impronta digitale, in quella della politique des auteurs; la sua persistenza cerebrale e retinica adesso, nella deriva postpellicolare.
Negli anni Mann, almeno da quando è stato tardivamente riconosciuto come figura autoriale a tutto tondo, ha subito l’accostamento a colleghi come Kubrick (maestro riconosciuto, e molla per la sua vocazione cinematografica con Il dottor Stranamore), Scorsese (coetaneo, amico e complice ai tempi di The Aviator), Nolan (allievo riconoscente e citante).
Ma, per esempio, anche nel miglior Scorsese, di fronte all’inquadratura più riuscita, capisco – da dove viene, dove va, le fonti, le variazioni, il talento nell’idearla, la bravura nel realizzarla. Capisco, appunto. Di fronte a certe inquadrature di Mann, viceversa, confrontandomi con quelle singolarità percettive tese a una sintesi ogni volta provvisoria, che cingono in un tratto unico la complessità, l’icasticità, la norma e l’eccezione, non capisco: non so da quale pianeta vengano, come diamine sia riuscito, non dico a concepirle, piuttosto a coglierle nel flusso dell’esistente, da lì a farle irrompere nella carne audiovisiva. E “una bellezza inesplicabile ci è più cara di una bellezza di cui riusciamo a scorgere le finalità”, Emerson docet.
D’altronde, a parità di perfezionismo, i film di Kubrick sono ritratti fedeli del cervello dell’artefice e, per quanto notevole fosse quel cervello, alla lunga il suo lavorio tende ad asfissiare le collegate emanazioni plastiche, a imprigionare l’immaginario nelle sue spire. Laddove i film di Mann sono straordinarie (a volte quasi rosselliniane) aperture all’esistente che nel tutto apparente celano innumerevoli interstizi di senso.
Se quelli di Kubrick sono film-cervello, quelli di Nolan sono film-meccanismo: architetture tecniche dove una complessa teoria di ingranaggi interagisce per mettere in moto la macchina, macchina il cui funzionamento verrebbe compromesso dall’intrusione di un qualsiasi spiffero di vita tra le pulegge. A parità di complessità, quelli manniani sono invece film-organismo, che vivono di loro proprie regole interne di sviluppo, senza che vi si ravvisi a ogni istante la mente che li guida, a tal punto la mente si è fusa con la creazione. (Non ci dilunghiamo qui sull’approccio ai generi, che in Kubrick/Nolan vengono gratificati dall’alto da iniezioni di intelligenza, laddove in Mann sono saturati dall’interno fino a deflagrare).
Ecco, allora, il touch, l’impronta digitale, il miracolo. È un’arte della contempl/azione, un’arte perennemente sulla soglia. La ferrea preparazione, l’intelligenza tattica, il controllo totale, non impediscono in Mann la densissima trama testimoniale, l’abbandono panico, il dispiegarsi di ogni senso all’erta. Le sue riprese a mano, gli shot aerei, le messe in quadro più composte riescono a convogliare nuance infinite perché il loro effetto non è predeterminato: è come se le decine e decine di ciak battuti facessero infine esplodere il mondo dentro l’obiettivo. Anzi, è proprio l’incontrastata padronanza “a monte” del mezzo che dona “a valle” la libertà di intercettare, con una naturalezza aliena all’ammicco di secondo grado, i suoi materiali: i dettagli modernisti, le pure estasi astratte, i deragliamenti semantici, l’efficacia hawksiana del gesto che rende più di mille estrinsecazioni verbali, la consapevolezza godardiana di un linguaggio in divenire. Concentrazione e apertura si rivelano complementari e si esaltano a vicenda, dialetticamente. Questa combinazione mi pare sia davvero unica, concorrendo a fare dell’opera di Mann uno degli apici (con la poesia monumentale di Malick e il titanismo sperimentale di Coppola) del primo secolo di evoluzione del cinema hollywoodiano. Ma poi, negli ultimi 15 anni, le possibilità del digitale di stabilire un nuovo paradigma dell’immagine hanno svelato scenari impensabili.
Piccolo flashback. 1982: intervistato da Wenders nella cannense Chambre 666 Antonioni diceva la sua sull’adattamento sensoriale alle nuove tecnologie dello sguardo, presagendo dai suoi vagiti su nastro magnetico la portata della rivoluzione digitale e ciò che avrebbe comportato nella pratica registica e nell’esperienza filmica. Quando finalmente si è compiuto il passaggio, nessuno più dell’autore di Chicago ha ripensato alla base le forme della visione, cucendole addosso ai nuovi strumenti di cineasta che s’è trovato tra le mani. Era d’altra parte un incontro di eccezionale tempismo e convenienza, perché nelle camere digitali di nuova generazione trovava il mezzo più adatto a espandere la poetica del flusso fenomenico già portata alle estreme conseguenze in Insider e Ali. In quest’ultimo si inauguravano le interpolazioni post-cinematiche che avrebbero rivelato tutta la loro potenza di fuoco sulle frequenze notturne di Collateral. Proprio mentre Scorsese (per citare l’esempio di maggior successo tra i coetanei) operava un processo di edulcorazione virtuosa dei propri procedimenti stilistici per non farsi fagocitare dalla macchina hollywoodiana, le possibilità inesplorate del digitale riattizzavano il sacro fuoco di un Mann sempre più younger than yesterday.
Eppure l’affaccio di Collateral sul paesaggio abbacinante e oscuro della Los Angeles after midnight fu un equivoco, una pia illusione. Era in fondo il suo saggio divulgativo sul cinema digitale, dove l’adesione (unica in carriera) a un congegno collaudato di sceneggiatura gli permise di sperimentare selvaggiamente senza troppo “disturbare” chi ha bisogno degli ancoraggi della prevedibilità narrativa. E infatti quando ha deciso di mollare gli ormeggi lanciandosi nella struttura free form di Miami Vice, per poi violentare la stilizzazione del gangster movie col salto tachionico dentro un passato trasformato in presente assoluto di Public Enemies, s’è visto come i poursuivres proprio non fossero in grado di tenere quelle velocità.
Le sue corrispondenze da terre incognite hanno infatti incontrato inusitate resistenze, anche da parte dei critici più intelligenti, col sacerdote della pellicola Tarantino che sparava a zero su Dion Beebe, e David Bordwell che confessava di non riuscire più a seguire Mann sul terreno minato delle textures di Public Enemies. Ma anche gli apprezzatori del campione di stile che trascenderebbe le trame formulaiche hanno capito poco di più della posta in palio. Al contrario, in lui la forma è in perfetta connessione con il pensiero; ovverosia, come postula Giona A. Nazzaro, Mann pensa per forme di cinema, forme che, aggiungo, partono dalle posizioni raggiunte per rilanciare ogni volta tutta la posta (ovvero i limiti della percebilità).
Più in generale, sembra essersi prodotto un gap incolmabile tra l’idea manniana di post-cinema, la sua fede incorrotta nel concetto di film d’arte da decine di milioni di dollari (ancora pienamente kubrickiano, in questo), e le aspettative ricettive, con la maggioranza di pubblico e critica a far la figura di antropologi dilettanti alle prese con una civiltà ignota della percezione audiovisiva di cui si ignorano riti e usanze.
Ostinandosi a giocare la sua sempre più trascendentale partita nel terrain vague tra commercio e avanguardia, Mann ha così (consapevolmente) rischiato di trovarsi da solo sulla sua bruciante frontiera sensoriale. Basti confrontare, per tastare il polso alle reazioni mainstream, i rating Imdb, Rotten Tomatoes, Metacritic degli ultimi film di Mann e quelli del succitato allievo Nolan, uno più che mai dentro le coordinate del cinema della smartness; ma anche con quelli del normalizzato Scorsese, che sul campo comune del thriller con infiltrati poteva farla franca presentando un abominio come The Departed, proprio mentre Miami Vice veniva definito da più d’uno il peggior film della storia.
Il backlash critico e la sordità del botteghino trovano in Blackhat un punto di non ritorno. Un twittatore arguto aveva previsto fin da prima dell’uscita che in questo caso la polarizzazione tra chi l’avrebbe amato e chi avrebbe avuto torto sarebbe stata ancor più estremizzata: bastava leggere le prime reazioni statunitensi per essere trascinati in un paradossale viaggio dal cosmic al garbage, ed è un punto d’onore che nonostante questa distonia percettiva Mann abbia continuato a mantenere saldi il rispetto e una commovente fiducia nelle capacità di discernimento pre-razionale dello spettatore (“so much of us is limbic-system response, and the amygdala will register dislike of something far more quickly than the cerebral cortex can think about it”).
Nella sua ennesima epopea del percepire, prima 100% digitale, lo schermo è sempre più un’interfaccia grafica deputata ad accogliere e processare il florilegio di grane, campiture, pesi specifici prodotti dalle diverse cineprese impiegate, tela mobile per uno sperimentatore più che mai in guerra coi dogmatismi, coi partiti presi formali. Un autore supremamente padrone della forma che sceglie di desacralizzare ulteriormente lo spazio stilistico dell’inquadratura per consegnarlo alla contraddittoria polifonia della realtà visibile e invisibile, intuendo che solo così il cinema può essere ancora in grado di confrontarsi con l’oceano di immagini generato dalla miriade di dispositivi che ognuno ha a disposizione per produrre il proprio punto di vista (che il sistema senza centro ha a disposizione per sorvegliare i propri sudditi), senza abdicare alla cogenza espressiva e al surplus significante dello sguardo che è stato appannaggio dei 24 fotogrammi al secondo.
Mann ha trovato il software ideale per convertire uno dei suoi grandi temi, da Thief in poi – la lotta sanguinosa del sentimento e dell’individualità contro la spersonalizzazione capitalista – nel nuovo millennio, dove l’alienazione liberista percorre come via privilegiata i circuiti della connessione globale. Non poteva che essere lui a dire la parola definitiva sugli spazi di manovra residui concessi all’individuo nella luminescente rete di comunicazioni che incatena la Terra, là dove il massimo della libertà apparente si salda all’acme della costrizione occulta; e, di conserva, sulle possibilità di un’arte superata dagli eventi come il cinema di tenersi al passo coi tempi, rimanendo capace di descrivere le traiettorie dei corpi, gli spostamenti d’aria, la densità fisica dell’immagine-reale, mettendole in pregnante relazione dialettica con il sostrato quantico, le logiche binarie che li innervano. In questo senso l’aggancio a nastro di Moebius dell’immersione subatomica iniziale nel language as a virus col suo corrispettivo materico, la processione del giorno del silenzio di Jakarta craccata dal movimento controcorrente dei blackhat, è un gesto davvero supremo, insuperabile. Come la progressiva scarnificazione della dimensione epica, la smaterializzazione dei personaggi che fa scalare a livelli inauditi il discorso di Miami Vice e Public Enemies, con quel finale indonesiano di pura sopravvivenza e vendetta, affine al cinema hongkonghese più radicale.
Coniugando le strutture instabili di Wong Kar-wai e i detour panasiatici di Johnnie To, una riflessione mai così stringente sulla propria carriera (la fiammeggiante autocitazione da Manhunter, gli addii de L’ultimo dei Mohicani, gli abissi di sguardi incrociati di Heat, senza dimenticare il proto-blackhat Benicio del Toro in Lucky Star) e una rinnovata libertà da B-movie nello sganciare i serbatoi svuotati dell’inessenziale per far emergere gli iconemi (skylines, schermi nello schermo, mezzi di trasporto, armi da fuoco, occhiali da sole), Mann sovrappone il paesaggio atopico della globalizzazione con i residui di un altrove assoluto, il silenzio dell’amore col rumore di fondo del profitto, gli eyes wide shuts e gli abbracci perduti, i lacerti del ricordare con l’arte più necessaria, quella della fuga.
Adieu au (vieux) language, benvenuti nel futuro.