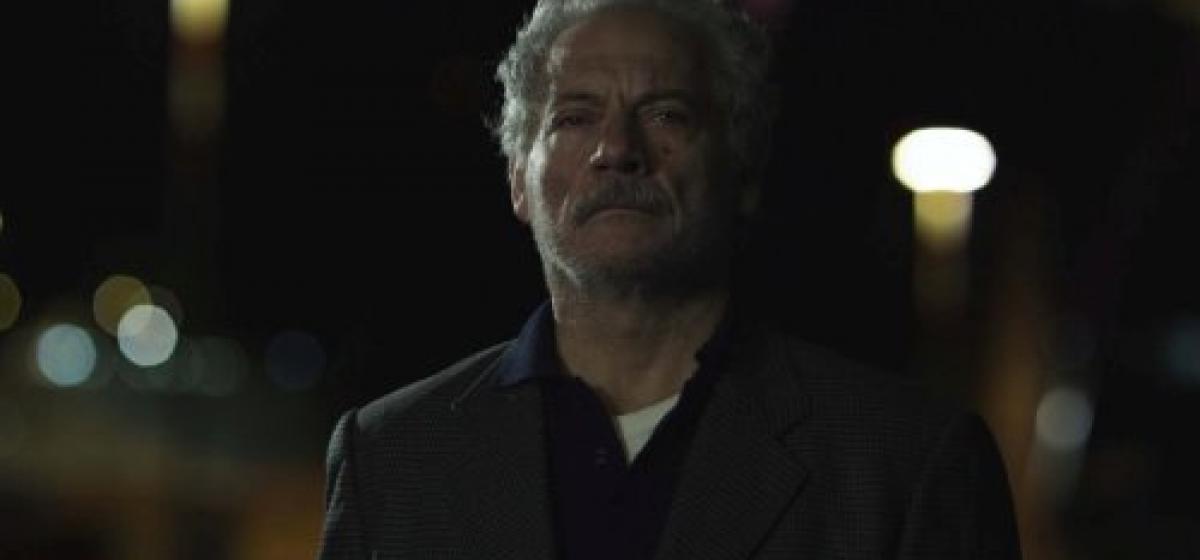“It’s just the wind” afferma Anna con tono rassicurante, da premurosa madre-bambina cresciuta troppo in fretta, rivolgendosi al fratellino Rio. Poi la mattanza.
E’ un film duro Just the wind (Czak a Szél); è una cazzottata che colpisce dritta allo stomaco. E’ un’opera scomoda, “fastidiosa”, proprio come quel ronzio di sottofondo che accompagna, scena dopo scena, le ultime azioni quotidiane dei protagonisti.
Mari, la madre, si sveglia alle prime luci dell’alba, prepara la colazione per il padre disabile, il quale vive con lei e con i suoi due figli in una baracca sporca e mal messa, nella periferia di una città ungherese. Di mattina è un’operatrice ecologica mentre di pomeriggio fa le pulizie in un istituto scolastico. Mari e le sue creature combattono tutti i giorni contro la brutalità e l’intolleranza del mondo ottuso che li circonda. Vivono con la paura costante che qualcosa di brutto possa sconvolgere le loro vite, come quelle di una famiglia vicina, sterminata qualche tempo prima da uomini sconosciuti.
Anna, la figlia, si alza poco dopo, si lava frettolosamente, zaino in spalla, percorre il sentiero che la conduce alla fermata dell’autobus e di lì a scuola. Malgrado la condizione in cui vive, Anna è una studentessa assennata, e nella scena in cui ripete con dedizione nella classe vuota la pronuncia corretta di alcune parole è racchiuso tutto il suo desiderio di cambiamento, la sua speranza di affrancamento, direzionata verso un destino migliore. Invece Rio, il ragazzino, ai banchi di scuola preferisce correre nell’erba dei campi, fare un bagno nel fiume, rovistare tra i rifiuti alla ricerca di una gomma d’auto con cui giocare. Se il desiderio di una vita alternativa per sua sorella è solo un’idea, Rio cerca di renderla materiale, attraverso la costruzione di un bunker sotterraneo, decorato ad arte con quel poco che trova qua e là; una seconda abitazione, insomma, in cui tappeti polverosi diventano divani comodissimi ed il poster stropicciato, raffigurante l’idolo locale di qualche teenager, un quadro meraviglioso. Cosa hanno di sbagliato queste persone? La loro unica colpa è essere degli zingari, dei rom, e questo alla restante comunità civile non piace. La società, quella stessa in cui si consuma silenziosamente lo stupro di un’adolescente negli spogliatoi della scuola, non perdona a Mari, Anna e Rio di essere in sostanza dei diversi.
Il regista Benedek Fliegauf, camera a mano, realizza una pellicola (tra l’altro, vincitrice del Gran Premio della Giuria durante la scorsa edizione del Festival di Berlino) in cui l’odore nauseante del Male, più che degli zingari, secondo una radicata quanto orrida opinione comune, riempie le narici dello spettatore. Brutalmente. In modo ansimante, così come le immagini mosse del film, si assiste al massacro di una famiglia, col pensiero agli omicidi compiuti tra il 2008 e il 2009 in Ungheria mediante bombe molotov e proiettili sparati con un’inarrestabile ferocia da assassini xenofobi. Tutti sanno ma nessuno avrà il coraggio di denunciare, come sempre accade.
Nella scena dell’omicidio gli spari sono lontani, i volti degli aguzzini oscurati dal buio della notte. Ed è come se il regista volesse, intenzionalmente, mostrare a chi guarda che i colpevoli, o meglio, i complici di quella carneficina non sono i singoli esecutori bensì tutti i cittadini del posto, adagiati nella loro compiacente omertà. La loro ipocrisia si materializza, alla fine, in un grigio obitorio, nel quale i corpi trivellati dai proiettili vengono inutilmente imbellettati affinché almeno nel viaggio verso l’aldilà acquistino una parvenza di decoro e pulizia. E’ questo il modo attraverso cui la società “civile” suole ripulire la propria, sporca, coscienza.