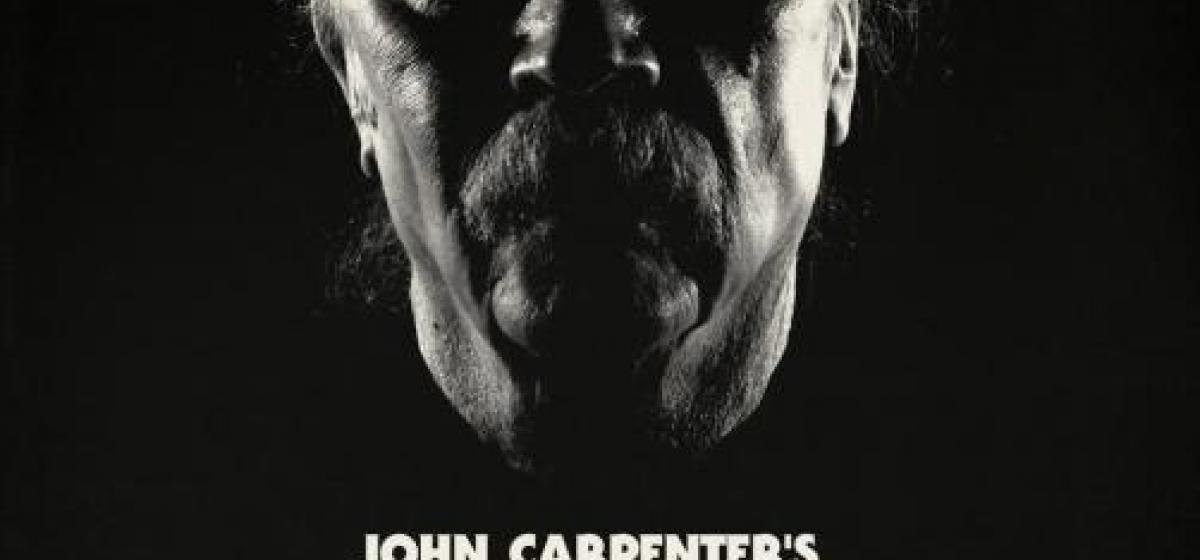Il ponte delle spie - L'importanza del manuale delle regole
Un cinema di simmetrie quello di Spielberg, da sempre, ma che in questo lavoro riallaccia il filo con gli anni d'oro del periodo classico

Come fare a prevedere la mossa successiva se non si conoscono le regole del gioco?
È una delle domande cruciali dell’ultimo film di Steven Spielberg, collocata nel cuore di un’opera di grandissimo rigore per la quale il posizionamento di sequenze, battute di dialogo, particolari movimenti di macchina e dichiarazioni di poetica assumono una valenza ineludibile.
Se il Max Von Sydow del Settimo sigillo scopriva se stesso giocando a scacchi con la morte, il Tom Hanks de Il ponte delle spie corre sulla scacchiera politica sottolineando l’importanza dei contorni, delle geometrie, delle leggi che governano ogni equilibrio, da quello ludico a quello costituzionale. Un cinema di simmetrie quello di Spielberg, da sempre, ma che in questo lavoro riallaccia il filo con gli anni d’oro del periodo classico, rigenerando lo spirito che fu e con esso quel ruolo che il cinema si assumeva la responsabilità di interpretare (in maniera molto simile a quanto fece De Palma con Gli intoccabili).
È così che anche Il ponte delle spie si sviluppa per opposizioni, in gran parte simboleggiate dall’immagine del ponte e da quella del muro, dove la prima rappresenta la struttura che unisce per antonomasia, mentre la seconda quella che divide. Architetture che si fanno immagini, bidimensionalità che si fa discorso storico, e la Storia, con le sue forme, che assurge a riflessione sul mezzo cinematografico e sul suo specifico.
Come unire etica e poetica? O meglio, come fare della loro compresenza la cellula generativa di un discorso sul cinema e sulla storia del secolo scorso? Pur essendo assieme agli altri movie brats un regista cresciuto studiando la storia del cinema all’università, sovvertire le regole del linguaggio cinematografico non ha mai rappresentato un obiettivo prioritario per Spielberg, specie se confrontato con la storia da raccontare o con il mito da abbracciare; c’è sempre stato molto più Truffaut che Godard nel suo cinema, tanto che lo stile non ha quasi mai rappresentato un pianeta a se stante, ma sempre qualcosa da esaltare tramite la narrazione, anzi, un involucro perfetto ed ergonomico, funzionale al suo contenuto. Non si tratta ovviamente di una generalizzazione da prendere alla lettera ma semplicemente di una tendenza ben precisa, seppur all’interno di una poetica riconoscibile come poche altre nel cinema contemporaneo, sia dal punto di vista tematico che linguistico.
Sulla scia del cinema della Hollywood Classica – delle opere di Capra, di Hawks, di Ford, ma anche di film meno connotati da un punto di vista autoriale come Casablanca – Spielberg fa de Il ponte delle spie un abbecedario del linguaggio cinematografico classico, innescando un processo di continuo punto e contrappunto tra la soluzione visiva utilizzata e la funzione ad essa assegnata. In un film che rilancia attraverso la luce bianca del proiettore cinematografico l’urgenza di una riflessione di ritorno sulla Guerra Fredda e su un manicheismo dialettico in cui il noi e il loro si incontrano e scontrano fino a confondersi, assume un ruolo di primo piano il montaggio parallelo. Non è un caso che il regista faccia ricorso a questa soluzione in numerose occasioni, a rimarcare quanto siano proprio i codici specifici come il montaggio i responsabili della costruzione del senso, come avviene nella sequenza che alterna la partenza della spia americana con la difesa disperata di Donovan in tribunale.
È il manuale delle regole la chiave interpretativa dell’opera: non solo perché simboleggia ciò a cui Donovan – personaggio hawksiano come pochi – si aggrappa per identificare se stesso e la sua americanità nel valore della professione, ma soprattutto perché queste questioni rappresentano il propellente di un discorso sul manuale delle regole cinematografiche e sul linguaggio classico come forma principe di espressione. L’amore per il canone è forte della consapevolezza che questo stesso canone rappresenta il lascito di un epoca che è stata definita ’Classica’ non a caso, nella quale quindi ogni transizione va pesata in maniera maniacale, tanto da far risultare le poche dissolvenze dell’opera (sia quelle incrociate sia quelle in/dal nero) sempre funzionali alla produzione di un discorso compiuto.
A pensarci bene, retrospettivamente, non sembra esserci nulla di più appropriato della Guerra Fredda per rileggere attraverso il linguaggio filmico i topoi del cinema di Spielberg, specie quando il discorso verte sul rapporto con la diversità e con l’altro da sé. Essere estranei a un cultura, a un linguaggio, a un sistema di segni ha sempre significato per l’autore l’occasione per mettere in moto un’indagine sull’umano, con l’obiettivo di tirare fuori il meglio da una cultura, in questo caso quella americana. Abel, spia russa prigioniera negli Stati Uniti, interpretata da uno straordinario Mark Rylance, non è null’altro che un alieno camuffato che attraverso l’incontro con l’essere umano ’tutto d’un pezzo’ intesse un rapporto di scambio culturale che non ha nulla di diverso da quello tra Elliott e il piccolo extraterrestre.
Da questo punto di vista il cinema di Spielberg si colora di momenti di grande autorialità, soprattutto nell’uso del controluce che investe Donovan e che, trasformandolo in una sagoma, universalizza il discorso. Un umanesimo che come sempre ha nella meraviglia la sua chiave di volta, a partire dallo stupore verso le reazioni del suo cliente (l’ormai celebre “would it help?”) che attraverso la conoscenza reciproca si trasformano in vere e proprie lezioni di vita. L’osservazione antropologica si fa quindi l’obiettivo privilegiato de Il ponte delle spie, tanto da guidare i movimenti di macchina verso la messa in campo delle figure umane, a cui viene data una centralità progressiva sequenza dopo sequenza, anche nei momenti che teoricamente dovrebbero essere dedicati all’azione più che alla riflessione.
Il passaggio dall’io al noi sarebbe doveroso se non fosse naturale per un cinema così responsabile come quello del regista de L’impero del sole: è una riflessione che dal soggetto passa alla comunità, dove quest’ultima è in prima istanza riconosciuta nella sua unità minima di riferimento, la famiglia, e successivamente si universalizza in un discorso più onnicomprensivo. Il ponte delle spie non può che incarnare anche, per forza di cose, un cinema di padri e sui padri, un lavoro dove il confronto e il passaggio generazionale vengono guardati al cinema e dal cinema, come nello straordinario montaggio alternato che alla missione dei genitori affianca l’educazione dei figli, o nella potentissima sequenza del documentario sull’atomica in cui alle morbide forme dei letali funghi atomici succedono le altrettanto morbide guance dei visi bagnati di lacrime dei bambini inquadrati in primissimo piano, quasi a ribadire l’insindacabile potenza dell’effetto Kulesov.
Il discorso sulla famiglia è prima di tutto un discorso sulla coppia, ed è tramite la messa in scena che Spielberg dice le cose più significative. Il gioco tra campo e fuori campo che domina la scena di dialogo tra Donovan e la moglie prima della partenza per Berlino si serve certamente di ottime battute di dialogo (“Dammi qualcosa a cui aggrapparmi non mi interessa che sia la verità”) con cui l’autore delinea l’ennesimo ritratto di moglie e madre, ma è soprattutto con la messa in scena e il montaggio che l’intera sequenza acquista senso, specie nel finale in cui la donna è inquadrata sola, con uno specchio alle spalle (che raddoppia il suo smarrimento), prima di sfumare nel nero con la prima dissolvenza del film. Allo stesso modo è stupefacente il rigore simmetrico della sequenza del ritorno a casa, in cui la stessa camera da letto e lo stesso specchio di prima sono ormai solo gli astanti di un’inquadratura che può finalmente riconciliare marito e moglie.
Non c’è linguaggio senza scrittura dunque, non c’è forma senza sostanza, non c’è espressione senza narrazione, e il discorso sul Secolo Breve si presta perfettamente a rimarcare questo modus operandi.
Quanta perfezione c’è in Donovan e Abel faccia a faccia ripresi dall’esterno della stanza e incorniciati dai riguardi della porta d’ingresso? Due uomini imprigionati dal cinema e poi liberati dal cinema stesso, due soggetti alle prese con una guerra gentile, nella quale autodefinirsi (come persone e come società) significa credere nell’insegnamento prima che nell’annientamento, nel buon esempio prima che nell’offesa. Scrittura e regia vanno a braccetto in un ballo che ha nel ritmo e nell’equilibrio le sue doti principali, come è più che evidente dalla bellissima scena di dialogo tra Donovan e l’ambasciatore russo, dove il più classico dei campo e contro campo viene portato avanti attraverso inquadrature sempre più ravvicinate, il cui climax è coadiuvato da una scrittura che trasforma il dialogo da un semplice negoziato in avvocatese in un botta e risposta fatto di minacce e allusioni atomiche.
La ripetizione si rivela come un’altra, fondamentale soluzione retorica. Vengono reiterati i luoghi, le azioni, le frasi (“Chi siamo noi, chi siamo noi”) i comportamenti, vengono raddoppiati i personaggi e i meccanismi narrativi, come quello che governa la macrostruttura del film dividendolo in due, dandogli altrettanti prologhi (che non a caso presentano i due esseri umani da scambiare, la spia e lo studente) e anche due location ben definite: New York e Berlino. Vi è la ripetizione dello stesso raccordo di sguardo che in un primo momento vede Donovan condannato dalla ’giuria popolare’ rappresentata dai passeggeri della metropolitana, per essere riabilitato nel finale sempre da quest’ultima e in particolare dalla stessa donna rispetto alla cui presenza la verosimiglianza cede il passo al messaggio di speranza dell’autore che non teme forzature narrative.
A proposito dello straordinario film di Laszlo Nemes Son of Saul, il filosofo francese George Didi-Huberman ha ribadito la necessità di fare ancora film sull’Olocausto, perché il mostro umano nel quale per anni ci siamo trasformati avrà sempre qualcosa da insegnare ai nostri contemporanei e alle generazioni future. Parafrasando questo discorso, Steven Spielberg ci dimostra che non ne abbiamo mai abbastanza di Guerra Fredda, in quanto l’apertura verso lo straniero necessiterà sempre di un sguardo verso un orizzonte più lontano, indipendentemente da chi abiti dall’altra parte del muro, che sia un sovietico o un alieno.