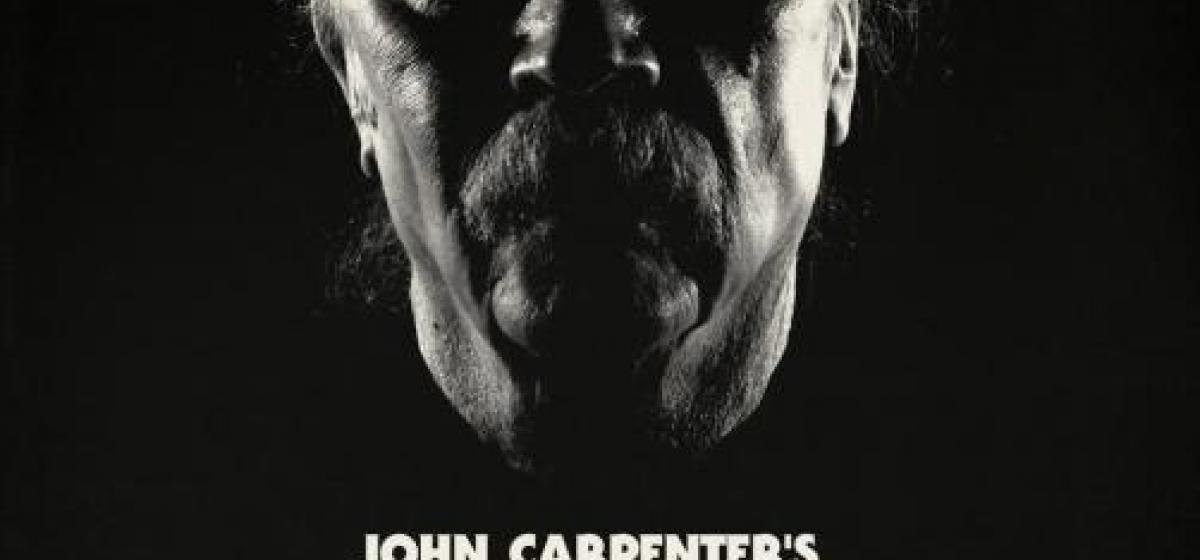Zemeckis / The Walk - In bilico sull'impossibile
Il cinema come atto funambolico, gesto antigravitazionale, flight dell'immaginario americano: The Walk è la magnifica summa dell'intera filmografia di Zemeckis.

L’abbiamo sempre saputo, sin dai tempi di Ritorno al futuro. Robert Zemeckis è il cineasta del vuoto, il regista americano attratto più di chiunque altro dalla vertigine, dall’equilibrio precario, dall’ebbrezza del volo. Non a caso il decennio della sua filmografia dedicato alla motion capture verte proprio su quest’idea di mancanza di supporti, di completa, animata elasticità. Il cinema per Zemeckis è atto funambolico, gesto atletico, flight dell’immaginario americano. A questo punto della sua carriera, non poteva che arrivare The Walk, summa incredibile della sua filmografia, la storia che, più di ogni altra, sembrava chiamarlo da una vita. Perché The Walk è figlio di quell’ossessione per il volo che dilania Danzel Washington nelle notti bianche di un alcolista. Questo prodigio stereoscopico ci racconta in filigrana la mirabile avventura del digitale, il sogno icariano di un corpo senza peso, libero da ogni tipo di supporto. Viene da pensare all’ardore ludico – e, di riflesso, politico - di chi sorpassa ogni limite per sentirsi vivo. Si pensa a Baumgartner che infranse il muro del suono in caduta libera, a Walter Steiner quando fermò il tempo nell’istante stesso del salto. Siamo di fronte a un cinema ginnico, aitante, primitivo e assieme futuristico, pronto com’è a inscenare quell’istante di sospensione dal mondo, di pura, deflagrante dilatazione del tempo. E’ il momento estatico della missione impossibile.
Era inevitabile dunque che Zemeckis rimanesse attratto dalla figura e dalla storia di Philippe Petit, il funambolo che camminò su un filo d’acciaio fra le Torri Gemelle per quarantacinque minuti. In miracoloso equilibrio su una linea orizzontale, Philippe Petit supera i limiti del possibile, sovrasta le verticalità monolitiche delle torri, dà vita a quel grande sogno che è poi il cinema. Le Twin Towers, dal momento della loro stessa comparsa, suggeriscono già un non-esserci-più mai manifesto. Si trovano lì, ospiti del nostro guardo, capaci di ammaliarci come fossero un ufo, uno spettro portato a nuova vita. Sul grande schermo, sembra dirci Zemeckis, le torri devono rimanere in piedi. In un cinema inteso come istituzione immaginifica di fantasmi, la presenza delle torri – l’omissione dell’11 Settembre – è una dichiarazione politica. E’ il gesto artistico di Petit a mantenerle in vita, come se al cinema fosse richiesto il compito di guarire la storia.
Ai piedi di Petit il precipizio, la profondità abissale di un’immagine centripeta, di un baratro in cui possiamo cadere. Le inquadrature stereoscopiche ci restituiscono un senso perduto di vertigine e d’instabilità: scivolare dentro lo schermo, immergerci in quel grande vuoto che è il cinema. Poter provare un sussulto di fronte alla paura folle di cadere nell’immagine, di perdere la propria stabilità, il proprio peso gravitazionale. Il 3D rivoluzionario di Zemeckis pone in volo il suo spettatore, lo disorienta, lo destabilizza, gli fa vivere il pericolo del crollo. Eppure, con estrema meraviglia, nessuno cade. Philippe è in equilibrio tra le nuvole, avanza e indietreggia con la grazia di un ballerino leggerissimo. E’ lontano da tutto e tutti, vive in una dimensione altra, in un luogo magico che si fa paradiso onirico, altrove celeste, regno della luce e del silenzio. Philippe è il cinema, non come lo era il treno di Lumière, ma nella sua accezione contraria: il vuoto non ci viene addosso, siamo noi a esserne attratti. L’immagine non esce dallo schermo, piuttosto sviluppa la sua profondità interna, cerca ossessivamente un retro impossibile. Siamo noi a perdere l’equilibrio, a scivolare nel cinema. Il 3D è finalmente una questione di profondità perché solletica le nostre stesse vertigini. Basta pensare alla cura maniacale di ogni piccolo dettaglio della città newyorkese vista dall’alto: possiamo distinguere automobili, strade, persone. L’immagine scava lo schermo, cerca il suo retrofondo illuminato, ci catapulta dentro, ci chiama al suo interno come il bianconiglio di Alice.
Petit, col suo sguardo ingenuo, ci guarda, invitandoci all’avventura. Egli è l’ennesimo piccolo grande uomo che si erge in piedi sul gorgo della Storia. La attraversa di sbieco e, devoto alla sua grande impresa, si ritrova per un attimo “al di fuori” dello scorrere delle cose, oltre i movimenti concentrici del mondo. E’ questo essere da un’altra parte il nucleo, il centro nevralgico, il cuore stesso del cinema di Zemeckis. Quest’altrove può essere di tempo (Ritorno al futuro), di luogo (Cast Away), d’aria (Flight), ma non fa differenza. E’ come se The Walk riesplorasse tutto il cinema del suo autore, tripartendolo all’interno della struttura narratologica più classica.
Nella prima parte conosciamo infatti Philippe Petit e i personaggi che lo circondano. Il ritmo è quello della fiaba parigina indiavolata in cui Zemeckis incontra Frank Capra e tutta la lievità eterna di tanto cinema che non esiste più. Qui assistiamo alla nascita della sua folle idea e immediatamente tornano alla mente le magie di Hugo Cabret, i colori della fiaba scorsesiana, il senso dinamico del racconto.
Nella seconda parte, invece, prende piede un autentico heist-movie, in cui la squadra di Petit programma la grande impresa quasi come se si trattasse di un attacco terroristico, il cui scopo però è l’esatto contrario: l’unico modo per portare un istante di bellezza nel mondo è un atto illegale, irresponsabile, contrario a qualsiasi norma civile. Quasi un sabotaggio del comune buonsenso. Assisteremo dunque alla follia acrobatica di Petit, in una lunghissima sequenza dove vengono sconfitti i limiti fisici del proprio corpo e quelli legali del corpo nazionale. Quasi un momento salvifico in cui non si cade ma si rimane in aria, provando tutta la gioia, tutto il candore, tutta la potenza di quella sospensione. Questo nuovo Forrest Gump è pronto finalmente a volare. L’eco mediatica non è la causa, ma l’effetto dell’azione, questo ci pare il punto essenziale del film. In un’epoca in cui ci propugnano la bellezza in qualsiasi, trita e ritrita forma di convenzionalissimo flash mob, l’azione di Petit nasce dalla fede incrollabile in un’idea che solo in un secondo momento avrà una risonanza pubblica (il flash mob, la società stessa dello spettacolo nascono invece – direttamente – con lo scopo di farsi evento).
Nella terza e ultima parte del film, ad azione già avvenuta, The Walk rilegge tante chiusure del cinema di Zemeckis, condensate nella sensazione struggente che l’avventura sia finita e non potrà più essere rivissuta. L’inquadratura finale alle Torri Gemelle rappresenta proprio questo: l’America è cambiata, solo il cinema può riportarla indietro, solo l’immaginazione può farci ancora sognare. Se il cinema americano non è più lo stesso dopo l’11 Settembre, Zemeckis riesce a fare un film che ha la consapevolezza della tragedia ma l’anima del cinema antecedente al crollo. C’è infatti una malinconia incredibile in queste ultime immagini: Petit può accedere alla terrazza delle Torri, guardare New York dall’altro, ricordare quel senso di vertigine che l’aveva fatto sentire vivo. Ma il tempo dell’azione è finito: come il protagonista di Cast Away che ritorna alla civiltà, come Doc Brown che distrugge la macchina del tempo, non rimangono che i ricordi delle persone che eravamo. La profondità delle immagini, lo scintillio della forma, il volto cartoonesco di Joseph Gordon-Levitt che (ci) guarda: al cinema, ancora una volta, vincono i sogni.