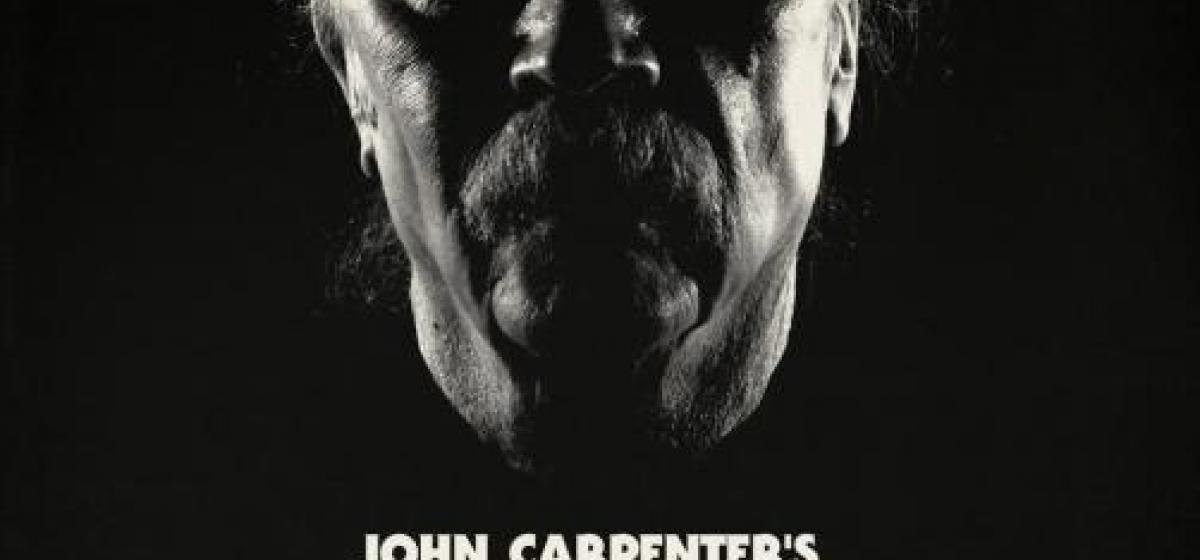Vizio di forma / Pynchon, tra fedeltà e tradimenti
''Vizio di forma'', o l'insostenibile solitudine di un cuore infranto.

Spesso si dice che il noir è un genere unico, estremamente ambiguo e suscettibile di stravolgimenti anche radicali, tali da piegarlo verso territori lontanissimi da quelli di partenza. Il noir è anche un genere definito retrospettivamente dai critici: nel 1955 Borde e Chaumeton pubblicano il saggio Panorama du film noir américain ovvero il primo testo che definisce un ampio corpus di opere sull’argomento e che, salvo alcuni precursori, individua il punto di partenza ne Il mistero del falco di John Huston del 1941. In quel film, adattamento del Falcone Maltese di Dashiell Hammett, l’ambiguità e la complessità del personaggio principale acquistano nuove sfumature, pari soltanto a quelle del contesto in cui sono immerse, fatto della “materia di cui sono fatti i sogni”, frase che Sam Spade pronuncia nel finale prendendola in prestito da Shakespeare.
Per certi versi è proprio la relazione tra il nero interiore del protagonista e la materia onirica la costante di un genere in continuo cambiamento, in grado di prestarsi perfettamente a ogni stile di scrittura, ivi compresa l’acida rappresentazione del contesto psichedelico della Los Angeles del 1970, filtrata attraverso la narrativa di genere, che Thomas Pynchon realizza nel 2009. Questo il punto di partenza di Paul Thomas Anderson , che per il suo settimo lavoro da regista sceglie un romanzo estremamente contraddittorio (come molti altri dell’autore) e ne scrive personalmente una difficilissima riduzione cinematografica. I nodi di problematicità non sono pochi e risiedono sia nella scelta (perché proprio quel libro di Pynchon?), sia nella realizzazione effettiva (a questo proposito sono stati tanti i critici che si sono concentrati sulla questione della fedeltà al romanzo).
La domanda più immediata è: cosa vuol dire fedeltà? E ancora: è sempre necessaria quando si lavora a un adattamento di tale prestigio? Lasciando da parte quest’ultimo quesito, o liquidandolo con un secco no che sancisce la libertà del cinema, il primo interrogativo risulta il più interessante. Sicuramente la fedeltà narrativa è qualcosa di ampiamente superato; spesso si dice infatti che un buon adattamento deve raccogliere lo spirito del testo da cui parte. In questo caso ciò che Anderson prende da Pynchon è senza dubbio il processo, una lavoro sulla storia e sulla propria forma espressiva che utilizza il linguaggio (ciascuno il suo) come cifra del cambiamento, della mutazione avvenuta con lo scorrere inesorabile degli anni.
Pynchon e Anderson in fondo fanno lo stesso lavoro, tornare con la memoria agli splendori passati in cui loro e la loro arte erano nel momento di massimo fulgore, e provare a guardarli con altri occhi e con altri esiti, offrendo certamente l’assist per parlare di nostalgia, ma andando decisamente oltre, soprattutto nel caso del lavoro del regista. Se è vero come è vero che Vizio di forma rappresenta il terzo capitolo di un discorso organico sulla storia americana, allora ha un senso molto preciso la scelta di prendere un libro di Pynchon che guarda al passato con gli occhi del presente, qualsiasi essi siano. Inutile dirlo, in entrambi il legame è racchiuso da quella parola totemica che ha segnato diverse decadi della letteratura come del cinema: postmoderno. Entrambi gli autori hanno avuto un ruolo centrale nella definizione e nella sistematizzazione del concetto di postmodernismo relativamente alla propria arte, così come entrambi fanno del loro Vizio di forma un modo per rapportarsi a quella stagione. Nel 1965 infatti esce L’incanto del lotto 49 , da molti considerato uno dei testi più rappresentativi dell’opera di Pynchon e più in generale della letteratura postmoderna. In maniera abbastanza speculare, Paul Thomas Anderson realizza, nella seconda metà degli anni Novanta, alcuni film cruciali riguardo al postmoderno cinematografico (su tutti Boogie Nights e Magnolia ), per poi, da Il petroliere in poi, allontanarsene in maniera radicale per portare il proprio cinema verso altri lidi.
Queste ragioni ci conducono a una semplice ma efficace equazione: Vizio di forma (libro) sta a L’incanto del lotto 49 come Vizio di forma (film) sta a Boogie Nights . Non è un caso poi che, a busta chiusa, dal punto di vista narrativo, Vizio di forma sia stato definito un prequel di Boogie Nights , tuttavia dal punto di vista stilistico e precisamente per l’utilizzo del linguaggio cinematografico, l’approccio del regista è totalmente diverso.
Se lo sguardo di Pynchon è quello di chi oggi ricorda un tempo ormai passato attraverso il filtro della nostalgia e dell’omaggio, rimanendo sempre estremamente divertente, quello di Anderson è decisamente differente e per certi versi più stratificato. Innanzitutto il focus è meno centrato sulla resurrezione di un contesto collettivo, ma più sull’emersione da quest’ultimo di alcune figure simbolo, di alcuni ruoli che segnano il romanzo e si fanno in prima persona alfieri di una trasfigurazione dell’epoca storica. Come nei due film precedenti, l’autore di Ubriaco d’amore , lavorando su epoche storiche ben precise in modo retrospettivo, non si tira indietro dal darne un giudizio. Meglio, nel processo rabdomante di resurrezione della grande storia americana, Anderson prende la posizione dell’osservatore esterno che guarda con estrema lucidità (a dispetto, in questo caso, di un soggetto tutt’altro che lucido) un periodo storico molto definito e messo in scena dal cinema hollywoodiano fin dal suo divenire.
Sebbene il cuore narrativo e profilmico dell’opera possano suggerire un linguaggio lisergico e allucinato, conducendo a paragoni con il Paura e delirio di Gilliam o con l’onirismo nichilista del Lebowski coeniano, il lavoro di Paul Thomas Anderson possiede tutt’altro rigore, prima di tutto espressivo, volto a guardare lo sfaldamento dell’utopia di un decennio (mai scissa dall’utopia di un soggetto) con lo stesso atteggiamento critico, problematico e dialettico adottato nei due precedenti lungometraggi. Vi è infatti un uso costante di estabilishing shot atti a stabilire i contorni di un quadro in cui il “detective” Doc Sportello viene prontamente escluso con dei progressivi, lentissimi movimenti di macchina in avanzamento (in alcuni casi fatti con un lento e inesorabile uso dello zoom), indicatori di un contesto respingente, alienante, in cui il protagonista rappresenta tutt’altro che l’incarnazione della condivisione del flower power, bensì il suo brutale smascheramento. Sono proprio il contrasto fra il contesto rappresentato e l’assoluto rigore mostrativo della regia e dello sguardo adottato – tra il cosa e il come – che rendono questo lavoro parte di una trilogia (per ora) estremamente coerente e per certi versi, il gemello di The Master .
Il lavoro sulla narrazione fatto a partire dal romanzo è estremamente complesso e in alcuni casi addirittura radicale. Tenendo conto di una generale fedeltà verso la materia prima, che Anderson tratta con grande rispetto e ammirazione, non sono pochi i punti in cui la riduzione rivela soluzioni nuove e inaspettate. Da un punto di vista generale, il paradosso maggiore consiste nel prendere un autore considerato dalla gran parte degli osservatori tra i più complicati da adattare al cinema e realizzarne una versione ancora più radicale dal punto di vista narrativo. Se, infatti, il romanzo di Pynchon, tenute presenti le caratteristiche inconfondibili della prosa dell’autore, si differenza dai lavori del passato denotando una maggiore aderenza a una narrazione forte e legata alla letteratura di genere, Paul Thomas Anderson porta il racconto alla suo più drastica polverizzazione, facendo esplodere completamente l’aspetto della detection, che nel libro possiede una maggiore linearità. In particolare la focalizzazione interna del racconto porta a una concatenazione di eventi che perde quasi sempre la sua natura consequenziale per abbracciarne una di carattere spiccatamente concettuale, una sorta di rappresentazione audiovisiva di ripetute associazioni mentali effettuate sotto l’effetto distorcente della cannabis. A questo livello il limite tra sogno e realtà diventa davvero sottile, così come quello tra il passato e il presente, in un incastro di scatole cinesi volto a rappresentare il mosaico della mente di Doc Sportello, dove i tasselli mancanti superano di gran lunga quelli decodificabili e dove a ogni nuova scoperta si moltiplicano esponenzialmente i punti interrogativi.
Come nel libro e in maniera ancora più esasperata, Doc sportello è naufrago nella stessa sua investigazione, la quale confina e si interseca con un labirinto prima di tutto mentale. Quello del protagonista è un mondo di fantasmi, dove i morti si scoprono vivi e questi ultimi in certi casi non lo sono mai stati realmente – “Like gone but not gone” . La resurrezione dei personaggi ha lo stesso statuto di quella del ricordo ed è veramente impossibile in certi casi (oltre che poco utile) capire dove finisca il reale e dove cominci l’allucinazione/ricordo/proiezione del protagonista, il quale è perennemente disperso nel vortice delle proprie lost highways dalle quali non vuole e soprattutto non riesce a uscire indenne. Lo stesso personaggio di Sortilège – quello che, non a caso, subisce la più profonda mutazione nel passaggio dalla carta alla pellicola – smette completamente di essere il carattere corporeo seppur contemplativo e riflessivo che era nel libro di Pynchon, per assumere una natura di tipo allucinatorio. La donna infatti diventa un’entità fantasmatica generata dal protagonista, voce narrate del film e bocca nello stream of consciousness interiore di Doc. Simbolo semi-materico della sua schizofrenia, Sortilège rappresenta il veicolo narrativo deputato a innescare quel meccanismo di vai e vieni tra presente e passato, tra ricordo nostalgico e disillusione che sta alla base della tossicodipendenza attuale del protagonista.
Sin dal testo pynchoniano la figura di Doc Sportello è in bilico tra reale e ideale, tra un modello dai contorni più o meno definiti ma sempre comunque caratterizzato da una oggettiva performatività, una sorta di voler essere del protagonista e dall’altra parte la costante incapacità di riuscire ad aderirvi. Se nel romanzo Sportello è attratto da un ideale maschile più legato alla letteratura e al cinema di genere, che trova spesso la sua concretizzazione nei personaggi interpretati da John Garfield, nel film l’incompiutezza è molto più intima e declinata tramite una sensazione di costante malinconia, di rimpianto nei confronti di un amore perduto e di un’incessante sofferenza per la mancanza della donna amata.
Sono di grandissima efficacia da questo punto di vista le due sequenze accompagnate dalla musica originale di Neil Young. Nella prima Sportello sotto le note di Harvest , dopo aver ricevuto un’ambigua telefonata circa la fuga/rapimento di Shasta (voce reale o immaginazione?) cerca col binocolo puntando verso l’orizzonte l’immagine/idea della donna di cui è ancora innamorato; dopo un’inquadratura del veliero della Golden Fang che si allontana in alto mare (immagine puramente metaforica) segue un primo piano di Shasta sorridente (vera e propria immagine mentale), avvolta da un rosso denso e passionale in contrasto con il malinconico blu in cui è immerso Doc, evidenziando così il preciso lavoro del direttore della fotografia Robert Elswit. L’altra indimenticabile sequenza, divenuta in poco tempo tra le più celebri per via della perfetta interazione tra musica e immagini, è quella del montaggio musicale costruito su Journey Through the Past . Ancora una volta è un dispositivo di visione a innescare il viaggio nel passato di Doc: è infatti la cartolina della lasciata da Shasta a riportarlo a quell’idillio da cui non riesce e non vuole scollarsi, rappresentato alla perfezione dai movimenti di macchina che riprendono i due innamorati sotto la pioggia correre, fermarsi e poi abbracciarsi, scanditi dalla malinconica e al contempo romanticissima steel guitar di Neil Young.
Il vizio di forma emerge nel finale e dà senso all’intera impalcatura narrativa: le uova che si rompono, il cioccolato che si scioglie, quel vizio intrinseco, quella ferita insanabile, quella malinconia mista a nostalgia che pervade l’animo del protagonista e che diventa ben presto il vero oggetto della sua detection. Shasta si allontana tra le onde del mare, come un sogno infranto e mai più ricomponibile, esattamente come lo scrittore del Lungo addio atlmaniano che sparisce nel magma metaforico di un oceano notturno. Solo attraverso una presa di coscienza vera, reale, solo tramite l’accettazione di una mutilazione permanente e di un dolore cui convivere, solo interpretando il proprio radicale romanticismo come unica via per conoscere se stesso, solo allora Doc può avere la forza di guardare la luce dritta negli occhi, potendosi permettere anche un ultimo ghigno di autocompiacimento.