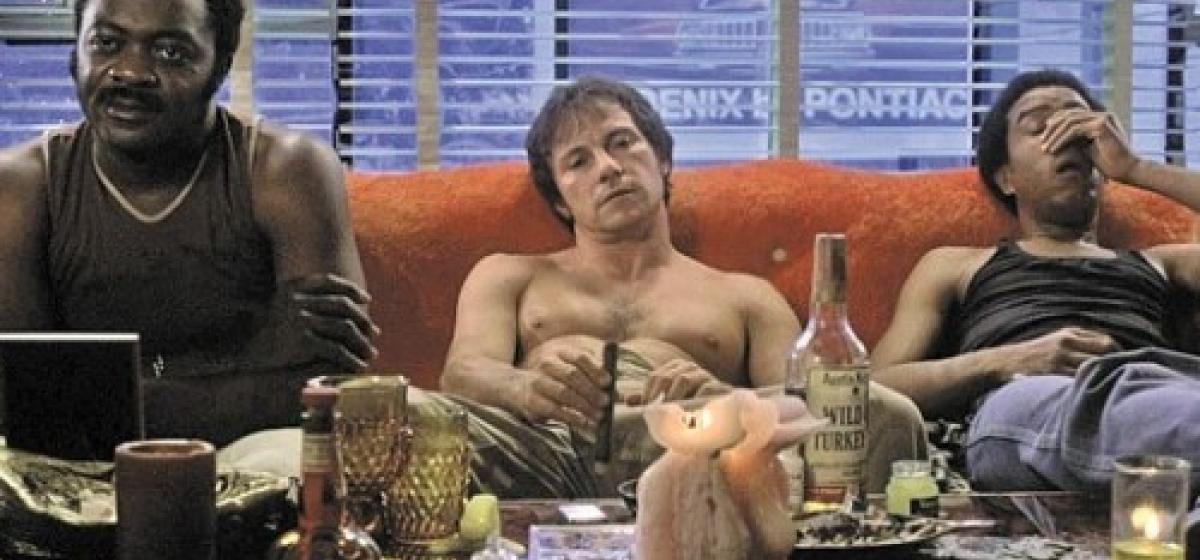La fuga dei due ragazzini scandita dal tempo dell’amore in Moonrise Kingdom aveva prodotto se non un cambiamento quanto meno un’apertura nel cinema simmetrico, iper-definito e iper-controllato di Wes Anderson. Aveva stabilito una deviazione, l’ingresso dell’irrazionalità dei sentimenti, capace di far saltare – al pari del tifone, che sempre nello stesso film si abbatteva poco prima del finale – il set, e con esso l’idea di una spazialità sempre addomesticata e addomesticabile, in qualche modo rassicurante, proprio come una casa di bambole, risolta nelle prospettive razionali, nella frontalità dell’inquadratura, nella definizione di un ambiente mappato. Per la prima volta i suoi personaggi si perdevano davvero, non per aderire al canone del film di viaggio, dell’on the road, quanto per ritagliarsi un angolo di mondo tutto loro, incontaminato, lontano dallo sguardo e dal controllo degli adulti. Ma non poteva durare. Giusto il tempo di un ballo in riva al lago, e di qualche bacio. Poi l’arrivo dei padri, naturali o adottivi, sanciva il ritorno alla quotidianità e dunque alle fredde mura domestiche.
Grand Budapest Hotel sembra scaturire da quella “sconfitta”, ovvero dalla consapevolezza che non c’è via di fuga dal mondo asfissiante che il suo stesso autore costruisce meticolosamente per i propri personaggi. L’unica soluzione paradossale è allora affrontare fino in fondo quest’ossessione spaziale, rinchiudendosi in unico ambiente – non a caso un albergo, figura ricorrente del suo cinema (I Tenenbaum, Hotel Chevalier) – che addirittura dà il titolo al film, e attorno al quale ruotano tutte le vicende. A tale ambientazione si aggiunge poi il ricorso ad un genere codificato, il giallo, e soprattutto l’adozione di un formato cinefilo, il 4/3, che al di là della sua motivazione “filologica”, ha come effetto più evidente quello di restringere ulteriormente il campo visivo e amplificare la frontalità del punto di vista. Ci si chiederà: ma allora dove sta la novità? Apparentemente dovrebbe trattarsi del film più “chiuso” di Wes Anderson, eppure non è così. La risposta sta nella frattura temporale che l’autore enuncia a partire dalle prime immagini e che sembra indicare una diversa prospettiva di fuga, ovvero nel tempo e nei ricordi. In questo modo Wes Anderson senza rinunciare al set come nucleo centrale del suo discorso filmico, lo svuota dall’interno. L’intreccio, anche molto divertente di per sé, per una volta passa in secondo piano rispetto al desiderio, ai sentimenti, che l’hanno innescato. In fondo, al regista non importa molto della storia, intuiamo come andrà a finire fin dalle prime battute. Ciò che conta è la volontà di conservare il ricordo, abitare la memoria e preservarla dall’oblio. Dopotutto, anche se per poco tempo, quel luogo è stato teatro di un amore e di un periodo felice nella vita di un uomo, e tanto basta per viverlo fino all’ultimo giorno della propria esistenza come solo luogo di appartenenza. L’immagine diviene allora uno spazio mentale, una sorta di zona franca atemporale, nella quale convivono tracce di tempi diversi. Il tempo della contemplazione, ovvero della lettura dell’opera; il tempo della creazione, in un certo senso diviso in due momenti distinti, uno visibile, l’intervista, e l’altro fuoricampo, la scrittura; il tempo dell’autore, che racconta davanti alla macchina da presa la genesi del suo racconto; e poi il tempo dell’azione, che risente ed è influenzato dallo stato d’animo del protagonista e narratore, che seleziona i ricordi, omette dettagli, stabilisce l’ordine e il senso della storia. A venir meno però è il presente, relegato ad un ruolo ancora più marginale rispetto al solito: mentre negli altri film esisteva come prodotto di un immaginario chiaramente rivolto e legato al passato, oggi viene ricondotto ad un tempo antecedente. In sostanza, non abbiamo più un passato mimetizzato nel presente, ma un presente totalmente riconducibile a ciò che è stato e non potrà più essere (l’amore, il gesto creativo).
Ne deriva il sentimento di profonda nostalgia che permea l’opera. Mai visto tanti morti e tanto sangue nel cinema di Wes Anderson come questa volta. Certamente si ride molto, forse anche più del solito, ma è la prospettiva infantile a venir meno. Il regista texano sembra finalmente essere cresciuto. E questa crescita, già segnalata nel precedente Moonrise Kingdom, sembra legata, proprio come per Tarantino, al tempo dell’amore e dell’avventura. Grand Budapest Hotel mette in scena la lenta, ossessiva ricerca di un’immagine-affezione stampata nei ricordi di un uomo: il primo piano di Saoirse Ronan che guarda innamorata verso la macchina da presa.